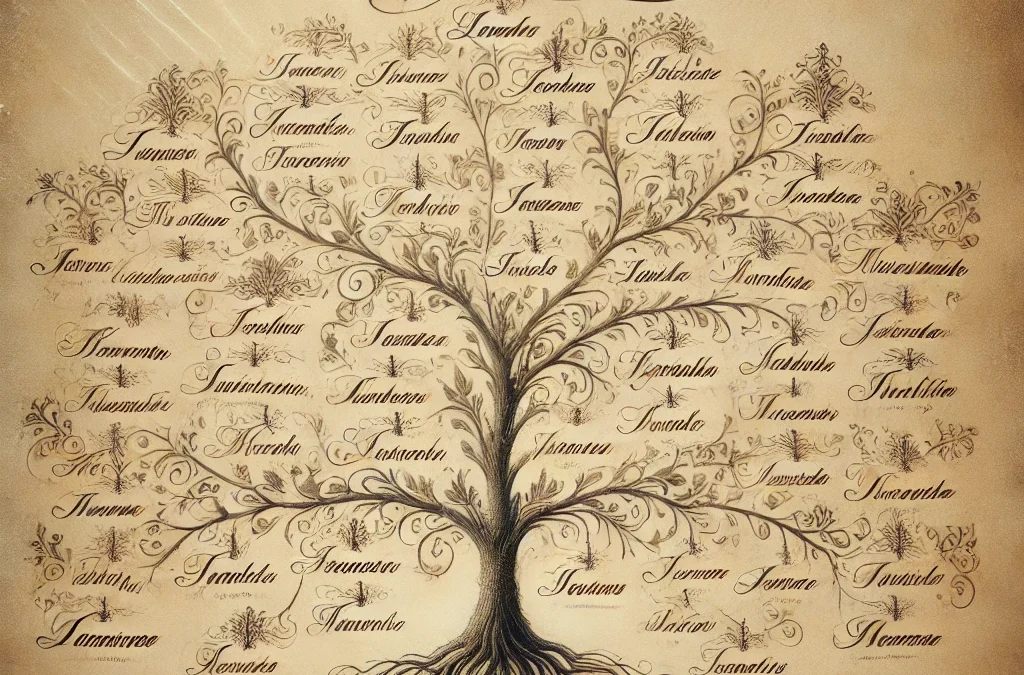da Redazione | Giu 4, 2025 | Diritto civile
Il contenzioso sui beni ereditari rappresenta una quota consistente delle cause iscritte presso i Tribunali italiani. È del resto risaputo che, tradizionalmente, la materia ereditaria è caratterizzata da un alto tasso di litigiosità.
La protezione dei diritti patrimoniali spettanti agli eredi o ai legittimari è avvertita come di primaria importanza anche dal legislatore, che offre ai privati numerosi strumenti di tutela. Accade frequentemente che, all’apertura della successione, il patrimonio relitto sia costituito da beni ereditari di natura immobiliare o mobiliare che, in assenza di un vincolo giuridico, possano essere alienati, trasferiti o dissipati prima che l’assetto definitivo dei rapporti successori sia accertato in sede giudiziale.
In presenza di controversie ereditarie — quali impugnative di disposizioni testamentarie, domande di riduzione per lesione della quota di riserva, azioni di simulazione o accertamento della qualità di erede — la durata fisiologicamente protratta del processo impone agli interessati di attivare strumenti di garanzia volti a preservare l’integrità dei beni ereditari.
Tra questi, il sequestro conservativo previsto dagli articoli 671 e seguenti del codice di procedura civile rappresenta una misura efficace per assicurare la futura soddisfazione di un credito di natura successoria, evitando che, nelle more del giudizio, il convenuto si spogli della propria garanzia patrimoniale.
Il presente contributo si propone di illustrare i presupposti per l’ottenimento di tale misura cautelare, evidenziando, anche attraverso l’analisi di ipotesi esemplificative, l’importanza strategica di proteggere tempestivamente i beni ereditari oggetto di contenzioso.
La durata dei giudizi successori e il rischio di dispersione dei beni ereditari
Le controversie ereditarie si contraddistinguono per la loro intrinseca complessità e per la frequente necessità di accertamenti di natura tecnica, documentale o persino peritale, che inevitabilmente incidono sulla durata del procedimento.
Nei casi in cui venga promossa un’azione di riduzione per la reintegrazione della quota di legittima, oppure un giudizio volto all’accertamento della falsità di un testamento olografo, il tempo che intercorre tra l’introduzione della causa e la pronuncia di una sentenza definitiva può superare diversi anni. In questo arco temporale, i beni ereditari oggetto di rivendicazione possono essere trasferiti a terzi, alienati a titolo oneroso, oppure consumati attraverso il prelievo di somme liquide e la dismissione di cespiti patrimoniali.
Tali evenienze compromettono gravemente l’effettività della tutela giurisdizionale e pongono a rischio il diritto sostanziale degli eredi lesi. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, a un coerede che, nominato erede universale in un testamento discusso, provveda a vendere l’unico bene immobile facente parte dell’asse, prima ancora che i legittimari abbiano avuto modo di agire in giudizio.
In simili circostanze, l’unica forma di tutela efficace è rappresentata dall’immediata richiesta di sequestro conservativo, in grado di preservare l’integrità dei beni ereditari e di garantire la soddisfazione coattiva delle future pretese riconosciute in via giudiziale.
Beni ereditari e sequestro conservativo: presupposti normativi
Il sequestro conservativo è una misura cautelare tipica prevista dall’art. 671 del codice di procedura civile, che può essere concessa quando si ha fondato motivo di ritenere che il debitore, nelle more del processo, possa sottrarre, disperdere o rendere inefficace la garanzia del credito. Nel contesto delle successioni ereditarie, tale misura assume un rilievo peculiare, in quanto consente di vincolare provvisoriamente i beni ereditari oggetto di contesa, impedendo che siano alienati o dismessi in pregiudizio degli altri eredi o legittimari.
La disciplina sostanziale di riferimento è contenuta negli articoli 536 e seguenti del codice civile, che riconoscono ai legittimari una quota di riserva sull’asse ereditario. Qualora tale quota sia stata violata, gli interessati possono agire in riduzione ai sensi dell’art. 554 c.c., ma affinché tale azione non rimanga inefficace, è spesso necessario attivare contestualmente una misura di carattere conservativo sui beni ereditari.
L’istanza cautelare può riguardare beni mobili, immobili o somme di denaro, purché si dia prova della fondatezza della pretesa ereditaria (fumus boni iuris) e del rischio attuale di danno irreparabile (periculum in mora). In assenza di tale presidio, il giudizio di merito potrebbe concludersi con un provvedimento favorevole ormai privo di concreta attuabilità, a causa della dispersione dei beni ereditari.
L’importanza del fumus boni iuris nei procedimenti cautelari sui beni ereditari
Il primo presupposto per l’adozione del sequestro conservativo sui beni ereditari è rappresentato dalla sussistenza del fumus boni iuris, vale a dire dalla verosimiglianza giuridica della pretesa che si intende tutelare in via cautelare. In ambito successorio, tale presupposto ricorre quando l’istante dimostra, anche solo in via sommaria, l’esistenza di una lesione della propria quota di legittima o l’illegittimità della devoluzione testamentaria.
L’ordinamento, infatti, accorda ai legittimari – quali il coniuge, i figli e, in mancanza, gli ascendenti – il diritto ad una quota minima e indisponibile dell’eredità, la cui violazione legittima l’esercizio dell’azione di riduzione ai sensi dell’art. 554 c.c.
Si pensi, ad esempio, a un soggetto che apprenda dell’esistenza di un testamento olografo, pubblicato a distanza di pochi giorni dalla morte del de cuius, con cui l’intera eredità venga attribuita al solo coniuge superstite, in palese pretermissione degli altri legittimari.
In tali circostanze, l’istanza cautelare può fondarsi sia sulla necessità di reintegrare la legittima, sia sull’eventuale dubbio in ordine all’autenticità della disposizione testamentaria. Il giudice, pur non essendo chiamato a un accertamento pieno, deve compiere una valutazione prognostica circa la fondatezza dell’azione principale e l’idoneità degli atti e dei documenti prodotti a giustificare l’adozione della misura sui beni ereditari.
Il periculum in mora e il pericolo di sottrazione dei beni ereditari
Accanto al fumus boni iuris, il secondo requisito essenziale per la concessione del sequestro conservativo sui beni ereditari è rappresentato dal periculum in mora, ossia dal timore fondato e attuale che la garanzia del credito successorio venga vanificata in modo irreversibile nelle more del processo.
Nel contesto delle liti ereditarie, questo rischio si manifesta con particolare evidenza allorché uno dei soggetti chiamati all’eredità – o che si dichiari unico erede sulla base di un testamento controverso – proceda, con estrema rapidità, alla dismissione del patrimonio ereditario, in modo da renderlo inaccessibile agli altri coeredi o legittimari.
Un esempio emblematico è rappresentato da quei casi in cui il soggetto in possesso dei beni ereditari vende un immobile, unico bene dell’asse relitto, a un terzo acquirente, riservandosi eventualmente l’usufrutto e trattenendo per sé il corrispettivo in denaro. In assenza di un provvedimento cautelare, il bene viene sottratto al patrimonio vincolabile e il prezzo della vendita, se non prontamente sequestrato, può essere trasferito, occultato o dissipato.
Il periculum in mora sussiste dunque ogniqualvolta si possa ragionevolmente ritenere che, al termine del giudizio, non vi sarà più alcuna garanzia idonea ad assicurare l’effettiva soddisfazione della pretesa ereditaria. La funzione del sequestro conservativo è, in questo scenario, quella di neutralizzare gli effetti dannosi del tempo, preservando i beni ereditari nella loro integrità sino alla decisione definitiva.
Il sequestro conservativo sui beni ereditari liquidi e immobiliari
Il sequestro conservativo può riguardare tutte le componenti attive del patrimonio relitto, siano esse costituite da beni immobili, mobili registrati, titoli o disponibilità liquide. Nel caso in cui i beni ereditari siano costituiti da immobili – quali fabbricati urbani, terreni o pertinenze – il vincolo cautelare potrà essere trascritto nei pubblici registri, impedendo il compimento di atti dispositivi che compromettano la garanzia del credito.
Analogamente, quando l’eredità comprenda somme depositate su conti correnti intestati al convenuto, il sequestro potrà essere eseguito presso l’istituto di credito, previa autorizzazione del giudice a compiere le necessarie ricerche telematiche a mezzo degli Ufficiali Giudiziari, secondo quanto previsto dall’art. 492-bis c.p.c.
L’estensione della misura ai beni ereditari di natura liquida assume particolare rilievo nei casi in cui l’immobile ereditato sia stato alienato e il relativo corrispettivo sia già stato incassato. In tali situazioni, l’unica forma di tutela utile per il legittimario che agisce in riduzione è vincolare le somme derivanti dalla vendita, prima che esse vengano distratte.
È dunque essenziale che il creditore ereditario agisca con tempestività, al fine di ottenere un decreto cautelare che consenta l’individuazione e il sequestro delle risorse economiche ancora disponibili. L’adozione di tale misura, oltre a preservare l’integrità dei beni ereditari, costituisce un importante strumento di pressione anche in vista di eventuali accordi transattivi o composizioni stragiudiziali.
Sequestro conservativo e azione ereditaria: il coordinamento con la tutela dei beni ereditari
La misura cautelare del sequestro conservativo deve essere sempre considerata strumentale rispetto all’azione di merito, la quale ha per oggetto l’accertamento di un diritto successorio. Nel caso di beni ereditari, tale azione può consistere, a titolo esemplificativo, nella domanda di riduzione di una disposizione testamentaria lesiva della legittima, nell’istanza di accertamento della nullità o falsità di un testamento olografo, oppure nella rivendica di un bene oggetto di attribuzione esclusiva a uno solo dei coeredi. L’art. 669-octies c.p.c. prevede che, qualora il giudice conceda la misura cautelare, debba essere fissato un termine perentorio – solitamente sessanta giorni – per la proposizione della causa di merito, la cui instaurazione è condizione di efficacia e stabilità della misura adottata.
Il ricorrente dovrà, dunque, agire tempestivamente, al fine di evitare che il sequestro decada per decorrenza del termine, pregiudicando così l’effetto di salvaguardia dei beni ereditari. La connessione funzionale tra cautelare e giudizio di merito impone inoltre che la domanda sia adeguatamente motivata, e che i documenti prodotti in sede cautelare siano coerenti con le prospettazioni che verranno sviluppate nella fase ordinaria. La tutela dei beni ereditari mediante sequestro, per essere efficace, deve quindi inserirsi in una strategia processuale più ampia, costruita con rigore giuridico e con piena consapevolezza delle dinamiche successorie in atto.
Mediazione e sequestro conservativo sui beni ereditari: compatibilità e funzione anticipatoria
In materia di successioni ereditarie, l’ordinamento prevede l’obbligo di esperire la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Tuttavia, l’obbligatorietà del tentativo di composizione stragiudiziale non preclude in alcun modo la possibilità di adire l’autorità giudiziaria in via d’urgenza per la richiesta di misure cautelari, e in particolare per ottenere il sequestro conservativo sui beni ereditari.
Tale possibilità è espressamente ammessa anche prima dell’instaurazione della procedura di mediazione, poiché la tutela cautelare non costituisce domanda di merito e risponde alla diversa finalità di prevenire il pregiudizio imminente e irreparabile derivante dalla dispersione della garanzia patrimoniale.
È anzi frequente che la decisione assunta in sede cautelare, proprio in ragione del suo contenuto prognostico, costituisca un punto di riferimento utile per le parti in vista di una risoluzione bonaria della controversia.
Un provvedimento che riconosca, anche solo in via provvisoria, l’esistenza di un credito successorio e ne tuteli la garanzia sui beni ereditari, può indurre la parte resistente a valutare con maggiore disponibilità un accordo conciliativo, sia nell’ambito del procedimento di mediazione che in sede stragiudiziale. In tal senso, la tutela d’urgenza non solo non ostacola la mediazione, ma può agevolarla, stabilendo un equilibrio processuale che disincentiva condotte dilatorie o elusive da parte di chi detiene beni ereditari in violazione delle quote riservate.
Consulenza legale e strategie di tutela sui beni ereditari
L’esperienza dimostra che le controversie ereditarie richiedono un’assistenza legale altamente qualificata, tanto nella fase preventiva quanto nella gestione giudiziale e cautelare del contenzioso. La presenza di testamenti controversi, la lesione delle quote di legittima, la simulazione di donazioni o la vendita intempestiva dei beni ereditari sono tutte circostanze che esigono valutazioni giuridiche accurate e interventi tempestivi, finalizzati a garantire l’integrità del patrimonio ereditario e la piena realizzazione dei diritti successori.
Il nostro Studio fornisce consulenza e patrocinio legale nelle controversie ereditarie più complesse, predisponendo strategie mirate per la tutela dei beni ereditari e per l’efficace esercizio delle azioni di riduzione, simulazione, impugnativa o accertamento della qualità di erede.
L’analisi preventiva della situazione successoria, accompagnata da un’eventuale azione cautelare e da un dialogo con le controparti in sede di mediazione, rappresenta spesso la soluzione più efficace per tutelare concretamente gli interessi degli eredi o dei legittimari, evitando l’irrevocabile dispersione dei beni ereditari e salvaguardando, al tempo stesso, la funzione sociale della successione.
Contattaci per un consulto.

da Redazione | Mag 7, 2025 | Diritto civile
Il contratto di sviluppo software è quell’accordo che disciplina gli aspetti essenziali del rapporto tra committente e sviluppatore in relazione alla creazione di programmi informatici. Pur non essendo espressamente tipizzato dal legislatore, il contratto di sviluppo si è affermato nella prassi quale accordo a contenuto variabile, modellato sulla base delle esigenze concrete del progetto e delle parti coinvolte.
L’obiettivo del presente contributo è quello di illustrare le principali clausole contrattuali che devono essere oggetto di attenta valutazione e regolazione in sede di negoziazione, al fine di prevenire incertezze interpretative, responsabilità impreviste o criticità operative nella fase esecutiva.
Saranno esaminati, in chiave sistematica, i profili relativi all’inquadramento giuridico della prestazione, alla definizione dell’oggetto, alla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, alle garanzie di funzionamento, alla protezione dei dati personali e agli obblighi di riservatezza, con l’obiettivo di fornire al lettore una guida chiara per la redazione o la verifica di un contratto di sviluppo coerente con i principi dell’ordinamento civile e con le best practices in materia di innovazione tecnologica.
Contratto di sviluppo: natura giuridica e qualificazione come contratto a causa mista
Il contratto di sviluppo di un programma informatico personalizzato presenta, sotto il profilo sistematico, una struttura complessa che si presta a una qualificazione giuridica di tipo misto, risultando talvolta riconducibile all’appalto, talaltra al contratto d’opera intellettuale, e non di rado configurandosi come negozio atipico a prestazioni corrispettive. A seconda delle modalità esecutive e delle clausole pattuite, tale contratto può infatti assolvere una pluralità di funzioni, le quali si riflettono sulla disciplina applicabile.
Nei casi in cui il fornitore si obblighi alla realizzazione completa di un software su misura, con consegna del risultato finale funzionante, trova applicazione la normativa in tema di appalto, con possibilità per il committente, in presenza di difetti, di avvalersi degli strumenti di tutela previsti dagli artt. 1667 e ss. c.c. In alternativa, qualora l’attività si esaurisca in una prestazione tecnica altamente specializzata e intellettuale, affidata a un prestatore d’opera non organizzato in forma imprenditoriale, la fattispecie può essere sussunta nell’ambito del contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. c.c., con eventuale applicazione della limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. in caso di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Tuttavia, nelle prassi commerciali più evolute, è frequente la presenza di clausole di esonero dalla responsabilità per mancato conseguimento di risultati, nonché di previsioni che escludono ogni garanzia circa la conformità del software a esigenze non esplicitamente rappresentate.
Tali previsioni depongono per la configurazione del contratto di sviluppo come prestazione di mezzi, e non di risultato, secondo l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale che ne ravvisa la causa tipica nel facere tecnico e non nel trasferimento di un bene finito. In questa prospettiva, è usuale inserire nei contratti formule esplicite, quali: “Il Committente riconosce che lo Sviluppatore non assume alcuna garanzia in ordine alla conformità del Software a uno specifico risultato, obiettivo aziendale o destinazione d’uso, salvo quanto espressamente previsto nel contratto”.
Tale impostazione è coerente con il principio di buona fede contrattuale, che impone una valutazione attenta del sinallagma alla luce della cooperazione del committente, della complessità del bene immateriale fornito e dell’effettivo contributo tecnico dello sviluppatore alla progettazione.
Contratto di sviluppo: determinazione dell’oggetto e articolazione delle prestazioni
Nel contratto di sviluppo, l’esatta delimitazione dell’oggetto contrattuale costituisce elemento di rilevanza centrale per la corretta individuazione delle obbligazioni assunte dalle parti. A differenza della semplice licenza d’uso di software standardizzato, il contratto di sviluppo presuppone un’attività progettuale personalizzata, calibrata sulle esigenze operative del committente, la cui attuazione comporta un facere qualificato, spesso articolato in più fasi tecniche.
In tale prospettiva, l’oggetto può includere sia la raccolta e l’analisi dei requisiti funzionali del sistema, sia la progettazione logica e l’implementazione progressiva di uno o più moduli software, fino al rilascio della versione finale dell’applicativo.
La prassi contrattuale più accorta prevede che il contratto sia strutturato in fasi autonome e progressivamente vincolanti: ad esempio, una prima fase di analisi e modellazione, una seconda fase di prototipazione o sviluppo di un “proof of concept”, e una terza fase eventuale di finalizzazione dell’applicativo definitivo.
Questa segmentazione favorisce la flessibilità operativa e consente di subordinare l’avanzamento del progetto all’esito positivo delle fasi precedenti. È inoltre frequente che l’oggetto contrattuale comprenda anche attività ulteriori, come il rilascio della documentazione tecnica, il supporto al collaudo, la manutenzione correttiva o evolutiva, la formazione del personale interno del committente e la consulenza in tema di proprietà intellettuale.
Al fine di evitare incertezze interpretative, è consigliabile che le parti definiscano sin dall’origine i confini dell’obbligazione, precisando le funzionalità richieste, gli standard attesi e le modalità tecniche di interazione con altri sistemi.
In tal senso, costituisce buona prassi allegare al contratto una scheda progettuale o un documento tecnico di accompagnamento, suscettibile di aggiornamento mediante accordi integrativi. Come recita una delle clausole-tipo frequentemente impiegate: “Il presente contratto ha per oggetto lo sviluppo di un applicativo personalizzato, secondo le specifiche tecniche e le tempistiche indicate nel documento progettuale allegato, che costituisce parte integrante dell’accordo”.
Obblighi delle parti, tempistiche di consegna e autonomia organizzativa nel contratto di sviluppo software
Nell’ambito del contratto di sviluppo, le obbligazioni assunte dalle parti non si esauriscono nell’individuazione dell’oggetto della prestazione, ma implicano un’accurata definizione degli oneri collaborativi e delle condizioni esecutive. Lo sviluppatore, in qualità di prestatore d’opera intellettuale, assume l’obbligo di eseguire l’incarico con la diligenza qualificata richiesta dalla natura specialistica dell’attività e secondo le specifiche concordate.
Tale obbligazione è, salvo diverso patto, da intendersi come obbligazione di mezzi e non di risultato, con applicazione del regime di responsabilità previsto dall’art. 2236 c.c. nei casi che comportino la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità.
Elemento centrale del rapporto è l’autonomia tecnico-organizzativa dello sviluppatore, il quale opera secondo modalità proprie, con facoltà di strutturare liberamente le fasi operative, di scegliere strumenti, collaboratori e ambienti di sviluppo, e di determinare la metodologia da adottare.
Tale autonomia esclude ogni rapporto di subordinazione e consente una più efficiente gestione del progetto, fermi restando gli obblighi di conformità ai requisiti previsti dal contratto. In sede negoziale, è frequente l’inserimento di formule che ne chiariscono la portata, quali “il fornitore eseguirà le attività in piena autonomia tecnico-organizzativa, restando responsabile del risultato solo nei limiti delle specifiche tecniche documentate”.
Specularmente, il committente è tenuto a collaborare attivamente fornendo tempestivamente dati, informazioni, documenti, ambienti di test, credenziali di accesso e ogni altro elemento ritenuto necessario dallo sviluppatore. Il ritardo o l’inadempimento in tali obblighi accessori può determinare il differimento dei termini di consegna, che decorrono normalmente “dalla data di ricezione completa dei materiali e della conferma di avvio del progetto da parte del fornitore”.
In progetti complessi, è consigliabile suddividere le attività dedotte nel contratto di sviluppo in stati di avanzamento (SAL), associando a ciascuna fase un obiettivo intermedio e un corrispettivo specifico, in modo da garantire una distribuzione proporzionata del rischio e del compenso tra le parti.
Responsabilità, garanzie e limitazioni negoziali nel contratto di sviluppo software
All’interno del contratto di sviluppo, la disciplina della responsabilità contrattuale e delle garanzie assume particolare rilievo, specie laddove l’attività dell’impresa incaricata implichi l’elaborazione di soluzioni personalizzate, innovative o fondate, ad esempio, su modelli di intelligenza artificiale.
Nella prassi, lo sviluppatore tende a limitare preventivamente il proprio rischio attraverso clausole che circoscrivano la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, come ammesso dall’art. 2236 c.c. per le prestazioni d’opera intellettuale implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
È frequente, ad esempio, l’inserimento di formulazioni in cui si prevede che “lo sviluppatore non assume alcuna garanzia in ordine alla correttezza dell’output generato dal software, trattandosi di sistemi basati su modelli predittivi o algoritmi non deterministici, la cui variabilità è intrinseca”. Clausole di tal genere sono pienamente lecite, purché non determinino un’esclusione assoluta della responsabilità per colpa grave o per inadempimenti essenziali, ipotesi vietata ai sensi dell’art. 1229 c.c.
Va evidenziato che, nel caso di contratto qualificabile come appalto, la normativa applicabile prevede in ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di eliminare i vizi dell’opera o ridurre il prezzo, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nonché la possibilità di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. qualora il difetto renda il programma del tutto inidoneo all’uso.
Tuttavia, qualora le parti qualifichino il contratto di sviluppo come prestazione d’opera intellettuale o come contratto atipico a causa mista, sarà possibile adottare una disciplina più flessibile e coerente con le peculiarità del settore, specialmente nei progetti in cui il risultato sia influenzato anche da elementi esterni alla prestazione del fornitore.
In sintesi, la corretta allocazione del rischio contrattuale tra committente e sviluppatore passa attraverso la redazione di clausole chiare, proporzionate e non vessatorie, idonee a distinguere tra obblighi di diligenza, obblighi di risultato e margini di incertezza fisiologici dei sistemi software in fase di sviluppo o prototipazione.
Proprietà intellettuale e diritti sul software
Uno degli snodi centrali nella redazione di un contratto di sviluppo è rappresentato dalla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale sul programma informatico realizzato.
In linea generale, lo sviluppatore – persona fisica o giuridica – è titolare originario dei diritti morali e patrimoniali d’autore sull’opera digitale, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Ne deriva che, salvo patto contrario, i diritti di utilizzazione economica sul software personalizzato non si trasferiscono automaticamente al committente con la sola stipulazione del contratto.
Nel contratto di sviluppo è quindi fondamentale stabilire se e in quale misura il codice sorgente sarà ceduto al committente, se con licenza esclusiva, non esclusiva o con facoltà di riutilizzo da parte dello sviluppatore.
In taluni casi, si potrà convenire che la titolarità rimanga in capo al fornitore, il quale concederà una licenza d’uso non esclusiva, “con facoltà per il cliente di modificarlo, impiegarlo per finalità commerciali e affidarlo a soggetti terzi per il completamento o la manutenzione del sistema”.
Resta sempre fermo che il diritto morale d’autore, in particolare il diritto alla paternità dell’opera, è inalienabile e imprescrittibile, e consente all’autore – o alla società che lo rappresenta – di rivendicare la propria qualifica di ideatore anche nei confronti del pubblico o della stampa.
Nella prassi, la cessione definitiva del codice sorgente avviene solo al termine di uno sviluppo completo e su pagamento integrale del corrispettivo pattuito. È consigliabile formalizzare detta cessione mediante un documento separato, allegato al contratto, che precisi in modo puntuale gli oggetti trasferiti, le modalità di utilizzo consentite e gli eventuali vincoli di esclusiva.
In mancanza, il rischio è che si creino incertezze interpretative o contenziosi sulla titolarità dei risultati, con effetti negativi sul valore dell’applicativo e sulla libertà contrattuale delle parti.
Contratto di sviluppo: un’assistenza legale dedicata
La crescente complessità tecnologica dei progetti digitali, unitamente al valore strategico che il software rappresenta per molte imprese, impone un approccio giuridico rigoroso e consapevole alla redazione del contratto di sviluppo. È essenziale che ogni clausola sia calibrata in modo da tutelare gli interessi economici delle parti, prevenire ambiguità interpretative, regolare in modo puntuale i diritti sul codice sorgente, le licenze d’uso, le responsabilità connesse all’output generato e gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali.
In questo contesto, lo Studio Legale D’Agostino offre una consulenza esperta a imprese, startup innovative e committenti pubblici o privati, con particolare competenza nei contratti aventi ad oggetto lo sviluppo di software, la proprietà intellettuale, la tutela del know-how e la compliance normativa applicabile al settore tecnologico e AI-based.
Lo Studio assiste i propri clienti sia nella fase di modellazione del contratto di sviluppo, nella negoziazione, sia nella predisposizione e revisione dei documenti contrattuali, condizioni generali e moduli d’ordine. Per ricevere un primo confronto, è possibile contattare lo Studio attraverso i recapiti disponibili nella sezione Contatti.

da Redazione | Apr 24, 2025 | Diritto civile
Il risarcimento del danno da lesione di animale domestico è, da molti anni, un tema “caldo” e al centro del dibattito giurisprudenziale. Nell’ordinamento giuridico italiano, il rapporto tra individuo e animale domestico ha progressivamente assunto una dimensione sempre più significativa, in virtù di un’evoluzione culturale e sociale che ha portato al riconoscimento del valore affettivo e relazionale dell’animale d’affezione.
Tale cambiamento si riflette, sempre più frequentemente, nella prassi giurisprudenziale, la quale ha mostrato un’apertura, seppur non unanime, verso la possibilità di riconoscere forme di tutela risarcitoria in caso di lesione di animale domestico, sia essa determinata da condotta colposa, dolosa o da inadempimento contrattuale.
Nonostante la qualificazione dell’animale, ai sensi dell’art. 812 c.c., come bene mobile, l’ordinamento ha introdotto nel tempo disposizioni volte a riconoscere agli animali d’affezione una specificità ontologica e relazionale. Ne sono espressione la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, la Legge quadro n. 281/1991, volta a promuovere e disciplinare la tutela degli animali d’affezione, nonché la Legge n. 189/2004, che ha inserito nel codice penale le fattispecie di reato a tutela del sentimento per gli animali.
Parallelamente, la giurisprudenza di merito ha talvolta riconosciuto la perdita o la lesione dell’animale come fatto lesivo di situazioni soggettive meritevoli di tutela, in quanto incidenti sulla sfera affettiva e relazionale del soggetto leso, tutelata ex art. 2 della Costituzione.
Alla luce di tale evoluzione, il presente articolo si propone di offrire una ricostruzione sistematica del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno per morte o lesione di animale domestico, illustrando le differenti basi giuridiche della responsabilità, le voci di danno risarcibili, i percorsi alternativi alla giurisdizione ordinaria e il ruolo centrale dell’avvocato nella piena tutela dei diritti lesi.
La tutela risarcitoria per lesione di animale domestico: tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale
La progressiva attenzione dell’ordinamento giuridico verso la lesione di animale domestico ha determinato un ampliamento delle categorie di danno suscettibili di ristoro, in particolare con riferimento alla possibilità di riconoscere non soltanto un danno patrimoniale, ma anche un danno non patrimoniale in capo al proprietario dell’animale o al soggetto affettivamente legato ad esso.
Il danno patrimoniale trova il suo fondamento normativo nell’art. 1223 c.c., applicabile anche in sede extracontrattuale per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2056 c.c., e comprende tutte le perdite economicamente valutabili subite dal danneggiato, in conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
Con riguardo alla lesione di animale domestico, si possono ricomprendere in tale categoria le spese sostenute per cure veterinarie, interventi chirurgici, accertamenti diagnostici, trattamenti terapeutici e, in ipotesi di morte dell’animale, il suo valore di mercato. In giurisprudenza si è evidenziato come tali voci siano risarcibili a prescindere dalla natura di razza o meticcia dell’animale, purché adeguatamente provate nel loro importo e nella loro derivazione causale dal fatto dannoso.
Ben più complessa risulta, invece, l’elaborazione giuridica del danno non patrimoniale. Ai sensi dell’art. 2059 c.c., esso è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. In tale ambito, assume rilievo l’art. 185, comma 2, c.p., che estende la risarcibilità ai danni non patrimoniali derivanti da reato, e l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2 della Costituzione, in base alla quale si riconosce tutela a diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla sfera affettiva e relazionale.
In questa prospettiva, talune pronunce di merito (Trib. Pavia, 16 settembre 2016; Trib. Venezia, 17 dicembre 2020; Trib. Pisa, 3 novembre 2023) hanno ritenuto che la lesione di animale domestico possa comportare un pregiudizio risarcibile non solo per il danno materiale, ma anche per la sofferenza morale e il turbamento psichico subiti dal soggetto danneggiato, configurando una lesione alla sua integrità affettiva.
Il riconoscimento del danno non patrimoniale non è tuttavia automatico, essendo subordinato alla prova dell’intensità del legame affettivo, della gravità del patema d’animo e della concretezza del pregiudizio subito. La valutazione giudiziale, pertanto, si sviluppa caso per caso, sulla base di elementi oggettivi e presuntivi idonei a dimostrare la centralità dell’animale nella vita del danneggiato.
La responsabilità extracontrattuale per lesione di animale domestico: l’art. 2043 c.c. e i presupposti di risarcibilità
La lesione di animale domestico può integrare, nei casi in cui non sussista un vincolo contrattuale tra le parti, un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (il quale sancisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). L’applicazione di tale norma comporta la necessità di accertare la sussistenza di un fatto illecito, la colpa o il dolo dell’agente, un danno ingiusto e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Con riguardo alla lesione di animale domestico, possono costituire fonte di responsabilità aquiliana, ad esempio, l’investimento dell’animale da parte di un conducente negligente, l’uso di mezzi pericolosi senza le dovute cautele, o atti di violenza gratuita su animali di proprietà altrui. Il fatto generatore del danno deve essere riconducibile con nesso causale diretto alla condotta illecita del soggetto agente e deve determinare un pregiudizio giuridicamente rilevante in capo al proprietario dell’animale.
Il danno è considerato “ingiusto” ogniqualvolta incida su un interesse giuridicamente tutelato, e la giurisprudenza più evoluta ha ritenuto che il legame affettivo tra il proprietario e l’animale d’affezione possa integrare un bene della vita rilevante ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, in quanto espressione del diritto all’identità personale e alla sfera relazionale.
In questo senso si è pronunciato, tra gli altri, il Tribunale di Venezia con la sentenza del 17 dicembre 2020 n. 1936, riconoscendo la risarcibilità del danno non patrimoniale in favore sia del proprietario dell’animale, sia del convivente, in virtù della comprovata relazione affettiva con il cane deceduto.
La prova del danno, in tali ipotesi, grava interamente sulla parte attrice, che è tenuta a dimostrare non solo l’evento dannoso e la responsabilità del convenuto, ma anche il nesso causale tra il comportamento illecito e la lesione di animale domestico, oltre alla serietà e concretezza del pregiudizio subito. Il giudice, accertata la fondatezza della domanda, potrà procedere alla liquidazione in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della documentazione probatoria offerta.
La responsabilità contrattuale o da contatto sociale qualificato per lesione di animale domestico: il ruolo del depositario e del professionista veterinario
Nel caso in cui la lesione di animale domestico si verifichi nell’ambito di un rapporto obbligatorio, quale un contratto di deposito o una prestazione d’opera professionale, trova applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c., secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. La responsabilità è, pertanto, presunta, e grava sul debitore l’onere di dimostrare l’assenza di colpa.
Emblematica, al riguardo, è la pronuncia del Tribunale di Prato del 2025, concernente la morte di una cagnolina affidata dai proprietari a una pensione per animali, in esecuzione di un contratto di deposito ai sensi dell’art. 1766 c.c. Il giudice ha ritenuto che la struttura fosse venuta meno all’obbligo di custodia e vigilanza, non avendo garantito la dovuta assistenza in presenza di sintomi di grave malessere, né avendo informato tempestivamente i proprietari, configurandosi un grave inadempimento dell’obbligazione principale. Il mancato attivarsi del depositario, pur avendo constatato le condizioni critiche dell’animale, ha determinato l’aggravamento della situazione clinica e, infine, il decesso dell’animale stesso.
Analogamente, nel rapporto tra cliente e veterinario, configurabile come contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c., trova applicazione l’art. 1176 c.c. in tema di diligenza, che, nel caso di attività professionale, deve essere valutata in relazione alla natura della prestazione e alle conoscenze tecniche richieste. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità del professionista è limitata ai casi di dolo o colpa grave, secondo quanto previsto dall’art. 2236 c.c.
Nella recente sentenza del Tribunale di Pisa del 3 novembre 2023 n. 1362, relativa a un caso di malpratica veterinaria per interventi chirurgici effettuati su un cucciolo affetto da grave displasia, il giudice ha accertato la responsabilità del professionista e della clinica per aver praticato una terapia operatoria inadeguata, che ha aggravato in modo irreversibile la condizione clinica dell’animale.
Pertanto, anche nell’ambito contrattuale, la lesione di animale domestico può costituire fatto idoneo a generare responsabilità risarcitoria per il debitore inadempiente, ogniqualvolta venga meno agli obblighi di diligenza, custodia o prestazione specialistica a cui è tenuto, con conseguente obbligo di ristoro del danno, secondo i criteri previsti dagli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c.
Le soluzioni alternative al processo nei casi di lesione di animale domestico: mediazione e negoziazione assistita
Nel contesto della lesione di animale domestico, l’ordinamento riconosce alle parti la possibilità – e, in determinati casi, l’obbligo – di ricorrere a strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria per la risoluzione delle controversie. In tale ambito si collocano due istituti fondamentali: la mediazione e la negoziazione assistita da avvocati, entrambi diretti a favorire una composizione consensuale della lite, con evidenti benefici in termini di celerità, economicità e minore conflittualità.
La mediazione, disciplinata dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, è obbligatoria quando espressamente prevista dalla legge come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Sebbene la lesione di animale domestico non rientri tra le materie elencate all’art. 5, comma 1, del decreto, essa può tuttavia ricadere in ambiti soggetti a mediazione obbligatoria in base al titolo giuridico del rapporto tra le parti. In particolare, qualora la controversia abbia origine nell’inadempimento di un contratto d’opera (come avviene nei casi di lesione conseguente all’affidamento del cane a una pensione o a un centro di addestramento), la parte attrice sarà tenuta a promuovere un tentativo di mediazione prima di poter agire in giudizio. L’omissione di tale passaggio processuale comporta l’improcedibilità della domanda.
Accanto alla mediazione, assume rilievo anche l’istituto della negoziazione assistita, introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. La negoziazione assistita è obbligatoria ogniqualvolta si intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di una somma non eccedente i cinquantamila euro, anche nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.
Pertanto, nei casi in cui il danneggiato intenda chiedere il risarcimento per lesione di animale domestico mediante richiesta di somma rientrante nella predetta soglia, la previa negoziazione rappresenta un passaggio necessario, pena l’improcedibilità dell’azione.
Tali strumenti si rivelano particolarmente adeguati in un ambito come quello della tutela degli animali d’affezione, in cui le componenti emotive e affettive si intrecciano con aspetti tecnici e giuridici, e in cui la ricerca di una soluzione condivisa può evitare l’ulteriore stress connesso al giudizio ordinario.
Lesione di animale domestico: supporto legale e tutela dei diritti
In una controversia risarcitoria relativa alla lesione di animale domestico l’assistenza legale può essere determinante sin dalla fase preliminare, per ricostruire i fatti nella loro esatta portata giuridica, valutare la documentazione probatoria disponibile e individuare le voci di danno risarcibile, con particolare attenzione alla qualificazione del legame affettivo tra il proprietario e l’animale d’affezione.
In ambito stragiudiziale, l’avvocato assiste il cliente nell’eventuale esperimento delle procedure di mediazione o di negoziazione assistita, assicurando il rispetto degli adempimenti procedurali richiesti e facilitando la definizione di soluzioni condivise, idonee a soddisfare in tempi ragionevoli le legittime pretese risarcitorie.
In sede contenziosa, la preparazione tecnica del legale diviene poi fondamentale per la redazione dell’atto introduttivo, per la costruzione del quadro probatorio, e per la corretta qualificazione delle singole poste di danno.
Il nostro Studio, grazie a una consolidata esperienza in materia di responsabilità civile, assiste i propri clienti nella gestione integrale di controversie aventi ad oggetto la morte o la lesione di animali domestici, con un approccio professionale che coniuga competenza tecnica e sensibilità per i diritti degli animali. Contattaci per un confronto, senza impegno.

da Redazione | Apr 8, 2025 | Diritto civile
Il ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) rappresenta una delle principali espressioni del diritto del cliente a ottenere giustizia in tempi rapidi e con costi contenuti, nell’ambito di un sistema che, in linea con le tendenze europee, promuove strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) idonei a decongestionare il contenzioso ordinario.
I rapporti tra consumatori, microimprese e intermediari finanziari sono infatti caratterizzati da una crescente complessità, che spesso sfocia in disallineamenti informativi e squilibri contrattuali. L’istituto del ricorso all’ABF, operante sotto la supervisione della Banca d’Italia, si inserisce in questo quadro quale presidio di tutela sostanziale, capace di offrire al cliente una risposta imparziale, fondata su criteri giuridici e prassi consolidate, senza la necessità di intraprendere un giudizio ordinario.
Il vantaggio primario del ricorso all’ABF risiede nella rapidità della procedura: a fronte di termini di definizione tendenzialmente contenuti entro sei mesi dalla proposizione del ricorso, il cliente può ottenere una decisione motivata, emessa da un collegio di esperti dotati di specifiche competenze in materia bancaria e finanziaria.
Ulteriore elemento di forza è rappresentato dalla economicità del procedimento, il cui costo è limitato alla somma di venti euro per il ricorrente, a titolo di contributo spese, con l’esonero da ogni onere legale obbligatorio.
Sebbene la procedura sia concepita in modo da risultare accessibile anche al cittadino privo di difensore, ciò non esclude che la presenza di un avvocato possa incidere in modo significativo sulla chiarezza delle argomentazioni giuridiche e sulla tenuta complessiva dell’istanza.
L’efficacia del ricorso all’ABF si misura inoltre nella sua capacità di offrire un punto di vista autorevole in ordine alla legittimità dei comportamenti tenuti dagli intermediari, contribuendo alla formazione di un orientamento uniforme nelle relazioni contrattuali in ambito bancario.
Le decisioni dei Collegi, pur non avendo valore giurisdizionale, influenzano la prassi del settore e sono frequentemente rispettate dagli operatori, anche per il rilievo reputazionale delle loro condotte. Il tema merita approfondimento, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità di presentazione del ricorso.
Ricorso all’ABF: natura, istituzione e fondamento normativo
L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie previsto dall’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), introdotto con l’intento di offrire ai clienti degli intermediari un rimedio stragiudiziale efficace, sotto il controllo istituzionale della Banca d’Italia. L’attuazione di tale previsione normativa è avvenuta con la delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, che ha disciplinato l’istituzione e il funzionamento dell’ABF, attribuendogli la competenza a decidere, su base documentale, le controversie tra clienti e operatori bancari e finanziari.
Il ricorso all’ABF si configura quindi come un meccanismo speciale, il cui fondamento normativo risiede in una disciplina primaria integrata da fonti regolamentari.
La natura dell’ABF non è giurisdizionale: si tratta infatti di un organo collegiale, autonomo nelle decisioni, ma incardinato funzionalmente nell’ambito delle competenze della Banca d’Italia, che svolge un ruolo di indirizzo e vigilanza sul corretto svolgimento della procedura.
I Collegi dell’ABF, istituiti su base territoriale, sono composti da membri dotati di elevata competenza giuridica ed economica, e decidono secondo diritto, anche tenendo conto dell’equità, come espressamente previsto dal regolamento attuativo. Il procedimento, che culmina nella decisione sul ricorso all’ABF, si svolge interamente in forma scritta, senza udienza pubblica, ed è fondato sulla valutazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
Sebbene le decisioni non abbiano forza di legge, l’intermediario è tenuto a uniformarsi salvo che non motivi espressamente il proprio dissenso, seguendo una particolare procedura che coinvolge la Banca D’Italia. Questo meccanismo di vigilanza indiretta, unito al prestigio dell’organo, contribuisce a garantire l’effettività del ricorso all’ABF, rendendolo un punto di riferimento stabile per la gestione delle controversie in materia bancaria.
Ricorso all’ABF: ambito di applicazione e tipologie di controversie trattabili
Il ricorso all’ABF può essere esperito in relazione a controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari, purché riconducibili a operazioni e servizi regolati dal Testo Unico Bancario, dal Testo Unico della Finanza o dalla disciplina dei servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Arbitro.
I soggetti legittimati a proporre ricorso sono i clienti persone fisiche, compresi i consumatori, nonché le microimprese, vale a dire quelle realtà imprenditoriali che, ai sensi della normativa europea recepita nel nostro ordinamento, occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. L’intermediario contro il quale si intende presentare il ricorso all’ABF deve essere soggetto vigilato, iscritto negli albi o elenchi tenuti dalla Banca d’Italia e operante in Italia, anche se con sede estera.
Quanto alla materia del contendere, l’Arbitro è competente a pronunciarsi su controversie relative a servizi e operazioni bancarie e finanziarie, tra cui l’apertura e la gestione di conti correnti, il rilascio di carte di pagamento, l’erogazione di finanziamenti, i contratti di deposito e le operazioni di investimento.
Rientrano inoltre nella competenza dell’ABF le problematiche connesse all’esecuzione di bonifici, all’addebito di costi non pattuiti, alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e all’inadempimento di obblighi informativi, specie in relazione alla trasparenza e alla correttezza delle comunicazioni con il cliente.
Il ricorso all’ABF non è invece ammissibile quando la controversia implichi l’accertamento di responsabilità extracontrattuale, l’esercizio di poteri discrezionali dell’intermediario o la valutazione di profili soggettivi che richiedano l’assunzione di prove orali o istruttorie complesse.
È inoltre necessario che, prima di proporre il ricorso all’ABF, il cliente abbia inoltrato un reclamo scritto all’intermediario, attendendo la risposta nel termine di sessanta giorni ovvero, in mancanza di riscontro, decorsi inutilmente i termini.
La tempestività è essenziale: il ricorso deve essere presentato entro dodici mesi dalla proposizione del reclamo. In questo quadro, l’Arbitro non si sostituisce al giudice, ma opera come strumento di verifica della correttezza dell’agire bancario alla luce delle fonti normative e degli obblighi di buona fede e diligenza professionale. La varietà delle materie trattabili e l’impostazione tecnico-specialistica del procedimento rendono il ricorso all’ABF uno strumento accessibile ma non privo di complessità, il cui corretto utilizzo presuppone una consapevolezza dei limiti e delle potenzialità dell’organo.
Ricorso all’ABF: procedura, fasi e decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario
Il procedimento che conduce alla decisione sul ricorso all’ABF è caratterizzato da semplicità formale e da un’impostazione interamente documentale, con lo scopo di assicurare rapidità e accessibilità nella trattazione delle controversie.
L’avvio della procedura è subordinato alla previa proposizione di un reclamo scritto all’intermediario, che deve essere presentato dal cliente entro i termini ordinariamente previsti, ossia non oltre dodici mesi dalla conoscenza dei fatti contestati. Solo in caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni o di risposta insoddisfacente, il cliente può attivare la fase successiva, mediante la proposizione del ricorso all’ABF attraverso il portale digitale dell’Arbitro, oppure per il tramite di una filiale della Banca d’Italia.
La presentazione del ricorso comporta il versamento di un contributo spese di modesta entità da parte del cliente, attualmente pari a venti euro, ed è seguita dalla notifica all’intermediario, che ha diritto di depositare controdeduzioni e documentazione difensiva entro il termine previsto dal Regolamento.
La decisione è assunta dal Collegio competente per territorio, in composizione collegiale, sulla base degli atti trasmessi e senza possibilità di udienza orale. Il procedimento si fonda sui principi del contraddittorio e della parità delle parti, ed è disciplinato secondo regole che garantiscono imparzialità, trasparenza e coerenza interpretativa. Il termine per la definizione del ricorso all’ABF è generalmente contenuto entro centottanta giorni dalla sua presentazione, salve le ipotesi eccezionali di proroga per la complessità della controversia.
Le decisioni dell’Arbitro, pur non avendo valore di sentenza e dunque non producendo effetti esecutivi diretti, sono normalmente eseguite dall’intermediario nei limiti dell’accreditamento presso la Banca d’Italia. La mancata ottemperanza può determinare conseguenze reputazionali rilevanti, anche alla luce dell’obbligo di pubblicare l’inadempimento sul sito dell’ABF e della Banca d’Italia.
Il cliente, in ogni caso, conserva il diritto di adire l’autorità giudiziaria, senza che l’esperimento del ricorso all’ABF precluda l’accesso al giudizio ordinario. Tuttavia, è opportuno precisare che, qualora il cliente proponga ricorso giurisdizionale durante la pendenza del procedimento dinanzi all’ABF, quest’ultimo viene archiviato per sopravvenuta inammissibilità.
La procedura arbitrale non può infatti svolgersi parallelamente al giudizio civile, in ossequio al principio di unicità del procedimento per l’identico oggetto. Il ricorso all’ABF mantiene dunque natura alternativa, ma non preclusiva, rispetto all’azione giudiziaria: il cliente può scegliere quale via percorrere, ma non attivarle contestualmente
Infine, è utile rappresentare che, in relazione alle controversie insorte tra clienti e intermediari bancari o finanziari aventi ad oggetto rapporti riconducibili alla disciplina del Testo Unico Bancario e del Testo Unico della Finanza, la proposizione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, laddove regolarmente introdotta e definita nel rispetto del Regolamento applicabile, può integrare – secondo l’interpretazione accolta in modo ormai prevalente dalla giurisprudenza di merito – una valida alternativa all’esperimento del procedimento di mediazione disciplinato dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
In particolare, il ricorso all’ABF, in quanto fondato su criteri di imparzialità, autonomia decisionale e rispetto del contraddittorio, è ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1-bis, del citato decreto legislativo, qualora verta sulla medesima questione che il ricorrente intenda successivamente far valere in sede giudiziale.
Resta tuttavia necessario che il procedimento arbitrale si sia effettivamente concluso, secondo i tempi e le modalità previste, e che l’oggetto del ricorso coincida sostanzialmente con quello della domanda giudiziale, onde evitare profili di inammissibilità derivanti da un improprio cumulo o da un uso disallineato dei rimedi alternativi previsti dall’ordinamento.
Ricorso all’ABF: frodi informatiche e responsabilità degli intermediari per carenze nelle misure di sicurezza
Tra le materie che sono talvolta sottoposte all’attenzione dell’Arbitro Bancario Finanziario figurano le frodi informatiche, purtroppo diffuse in ambito bancario, con particolare riferimento a operazioni di pagamento effettuate senza autorizzazione del cliente. Si tratta, in genere, di addebiti generati mediante tecniche di phishing, smishing o malware, o ancora a seguito dell’intercettazione di credenziali d’accesso e codici dispositivi.
In presenza di tali eventi, il ricorso all’ABF può rappresentare un rimedio potenzialmente utile per verificare la responsabilità dell’intermediario, specialmente nei casi in cui il cliente ritenga che le misure di sicurezza adottate non siano state idonee a prevenire accessi abusivi o utilizzi fraudolenti dei servizi online.
Alla luce del D.lgs. 11/2010, che recepisce la normativa europea in materia di servizi di pagamento, spetta all’intermediario dimostrare che l’operazione è stata eseguita correttamente, che è stata debitamente autenticata e che non vi siano stati malfunzionamenti riconducibili ai propri sistemi.
Le decisioni sinora pubblicate dall’Arbitro sembrerebbero accogliere una lettura piuttosto rigorosa dell’onere probatorio in capo all’intermediario, richiedendo un’attenta verifica delle modalità di autenticazione e dei meccanismi di protezione impiegati. Anche in presenza di autenticazione forte, non si escluderebbe, in via generale, la responsabilità dell’intermediario qualora emergano vulnerabilità strutturali nei sistemi di controllo antifrode o carenze organizzative nella gestione della sicurezza.
Nel contesto di una frode, il ricorso all’ABF potrebbe quindi offrire al cliente uno strumento celere ed economicamente sostenibile per far valere le proprie ragioni, senza la necessità di ricorrere immediatamente al contenzioso ordinario.
L’efficacia del rimedio dipenderebbe, naturalmente, dalla specificità del caso concreto e dalla documentazione disponibile.
Ricorso all’ABF: perché rivolgersi a un avvocato sin dalla fase del reclamo
Sebbene la procedura di ricorso all’ABF sia concepita come accessibile anche al cittadino privo di difensore, l’assistenza di un avvocato potrebbe rivelarsi determinante sin dalla fase preliminare del reclamo all’intermediario.
L’esperienza professionale nella gestione del contenzioso bancario consente infatti al legale non soltanto di redigere un reclamo formalmente corretto e completo sotto il profilo probatorio, ma anche di selezionare gli aspetti giuridicamente rilevanti e di inquadrare correttamente la fattispecie nel sistema delle fonti normative applicabili.
La presenza di un professionista abilitato sin dall’inizio del procedimento consentirebbe inoltre di evitare errori nella presentazione della documentazione o nella scelta degli argomenti, che potrebbero pregiudicare l’esito del reclamo o la strategia processuale complessiva.
Nel passaggio dalla fase del reclamo a quella del ricorso all’ABF, l’avvocato può offrire un contributo strategico, anche in considerazione del fatto che l’Arbitro decide sulla base esclusiva degli atti scritti e della documentazione allegata dalle parti.
La possibilità di avvalersi dell’assistenza di un legale, pur non obbligatoria, risponde quindi a una logica di ottimizzazione delle risorse difensive: la consulenza dell’avvocato consente di evitare percorsi inutilmente dispendiosi o non appropriati rispetto al caso concreto, e di predisporre una strategia coerente fin dalla fase iniziale del contrasto con l’intermediario.
Il ricorso all’ABF, se ben impostato, potrebbe risolversi in una decisione favorevole già in sede stragiudiziale, con evidenti vantaggi in termini di tempo, costi e contenimento del rischio, anche sotto il profilo delle ripercussioni patrimoniali e reputazionali per il cliente.
Ricorso all’ABF: vantaggi dell’assistenza legale
Il ricorso all’ABF si configura come uno strumento di tutela efficace e accessibile, che consente a consumatori e microimprese di far valere le proprie ragioni nei confronti di banche e altri intermediari senza dover affrontare i tempi e i costi del giudizio ordinario.
La struttura semplificata del procedimento, l’assenza di formalismi processuali e l’autorevolezza dei Collegi rendono l’ABF un punto di riferimento per la risoluzione delle controversie in materia di servizi bancari e finanziari, soprattutto nei casi in cui il valore economico della pretesa non giustifichi l’inizio di una causa civile.
In tale prospettiva, l’assistenza di un avvocato può rappresentare un fattore decisivo nella costruzione di una strategia efficace, già a partire dalla redazione del reclamo stragiudiziale.
Lo Studio Legale D’Agostino assiste da anni privati, imprese ed enti nella gestione di controversie bancarie e finanziarie, offrendo consulenza legale qualificata nei procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie, con particolare attenzione all’ambito dei sistemi ADR regolati dalle autorità di vigilanza. Contattaci per un primo consulto!
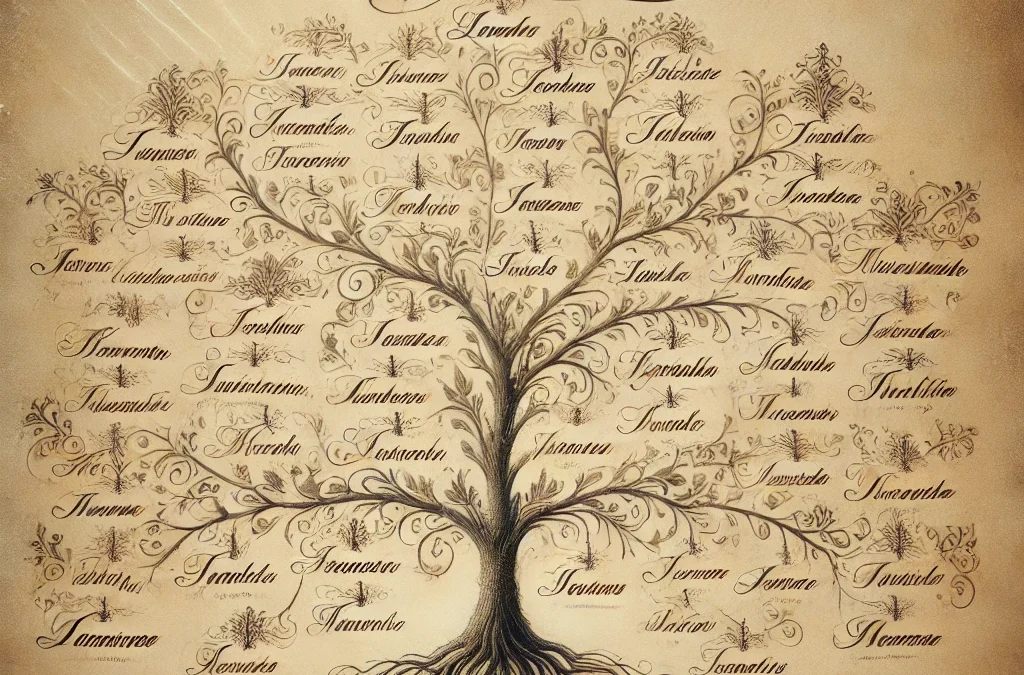
da Redazione | Mar 20, 2025 | Diritto civile
Le controversie in materia di eredità e successione sono tra le più frequenti nei contenziosi civili e, se non risolte tempestivamente, possono sfociare in lunghi e dispendiosi procedimenti giudiziari. Invero, la gestione di un’eredità può spesso generare tensioni e contrasti tra gli eredi, soprattutto quando vi sono beni indivisi, disposizioni testamentarie di dubbia interpretazione o soggetti che ritengono lesi i propri diritti successori.
Per prevenire tali criticità e favorire la composizione amichevole delle liti ereditarie, l’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di ricorrere alla mediazione civile quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).
La mediazione consente alle parti di dialogare con l’ausilio di un mediatore imparziale, con l’obiettivo di raggiungere un accordo che soddisfi le esigenze di tutti i soggetti coinvolti nella successione. Oltre a rappresentare un’opzione più celere ed economica rispetto al contenzioso giudiziario, la mediazione in materia di eredità e successione ha il pregio di preservare i rapporti familiari, evitando che le controversie degenerino in conflitti insanabili.
Il presente articolo analizza l’istituto della mediazione civile nel contesto successorio, illustrandone il funzionamento, i vantaggi e le principali tipologie di controversie ereditarie che possono trovare soluzione attraverso questo strumento.
L’istituto della mediazione civile in materia di eredità e successione
La mediazione civile è un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie che consente alle parti di evitare il ricorso all’autorità giudiziaria, favorendo il raggiungimento di un accordo con l’intervento di un mediatore imparziale.
In ambito successorio, tale strumento assume particolare rilevanza, poiché le controversie relative a eredità e successione spesso coinvolgono legami familiari e sentimentali che possono risentire di una lunga e complessa battaglia giudiziaria. La mediazione, al contrario, permette agli eredi di confrontarsi in un contesto più collaborativo, con l’obiettivo di trovare soluzioni che soddisfino le esigenze di tutti i soggetti coinvolti.
L’ordinamento giuridico italiano disciplina la mediazione civile con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il quale prevede che in determinate materie, tra cui le successioni ereditarie, la mediazione sia un passaggio obbligatorio prima di poter adire il giudice. Ai sensi dell’art. 5 del decreto, chi intende promuovere un’azione giudiziaria in materia successoria è tenuto preliminarmente a esperire il tentativo di mediazione. In mancanza di tale adempimento, il giudice potrà dichiarare l’improcedibilità della domanda e invitare le parti ad avviare la procedura di mediazione prima di proseguire il giudizio.
Oltre alla mediazione obbligatoria, la normativa prevede anche la mediazione volontaria, che può essere attivata su iniziativa spontanea delle parti in qualsiasi momento, anche in assenza di un contenzioso già avviato. In aggiunta, vi è la mediazione delegata dal giudice, che può essere disposta nel corso di un procedimento civile quando il magistrato ritiene che la controversia possa essere risolta in via extragiudiziale.
Indipendentemente dalla modalità di accesso alla mediazione, il procedimento offre un’alternativa vantaggiosa al contenzioso ordinario, sia in termini di rapidità che di riduzione dei costi, con effetti particolarmente positivi nelle dispute relative a eredità e successione, dove la necessità di una composizione amichevole è spesso essenziale per la tutela dei rapporti familiari.
Il procedimento di mediazione civile in materia di eredità e successione
La mediazione civile in materia di eredità e successione può essere avviata su iniziativa di un coerede o di un altro soggetto interessato che intenda risolvere una controversia ereditaria senza ricorrere immediatamente al giudice. Il primo passo è la presentazione di un’istanza presso un organismo di mediazione accreditato, nella quale devono essere indicate le generalità delle parti coinvolte, l’oggetto della disputa e le richieste avanzate.
Chi intende promuovere la mediazione deve valutare attentamente la propria posizione giuridica e impostare una strategia negoziale efficace, motivo per cui è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato con competenze in eredità e successione (diritto successorio). Il legale non solo assisterà il cliente nella redazione della domanda di mediazione, ma lo guiderà anche nell’individuazione degli obiettivi da perseguire durante il procedimento.
Chi riceve la convocazione in mediazione deve, a sua volta, adottare una strategia adeguata, valutando se partecipare attivamente alla procedura o se contestare la richiesta avanzata dalla controparte. Sebbene la mediazione sia formalmente un procedimento extragiudiziale, il mancato riscontro alla convocazione può comportare conseguenze sfavorevoli per la parte assente, sia sotto il profilo processuale che dal punto di vista della gestione dei rapporti familiari e patrimoniali. Per questa ragione, anche chi viene citato in mediazione deve farsi assistere da un legale, che potrà valutare la fondatezza della pretesa avanzata e suggerire le migliori opzioni difensive o transattive.
Una volta depositata l’istanza, l’organismo di mediazione nomina un mediatore imparziale e fissa il primo incontro, che deve svolgersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Durante questa prima fase, il mediatore illustra il funzionamento del procedimento e verifica la disponibilità delle parti a proseguire con la mediazione. Se entrambe le parti accettano di partecipare, il mediatore organizza una serie di sessioni in cui ciascuno degli eredi può esporre le proprie ragioni e proporre soluzioni per la risoluzione della controversia.
La durata media della procedura di mediazione in materia di eredità e successione è di circa tre mesi (salvi casi particolarmente complessi), termine entro il quale le parti devono cercare di raggiungere un accordo. Se la mediazione si conclude positivamente, viene redatto un verbale che ha valore di titolo esecutivo, il che significa che, in caso di inadempimento, potrà essere direttamente eseguito come una sentenza.
Qualora, invece, non si raggiunga un accordo, la procedura si chiude con esito negativo e le parti possono liberamente intraprendere un’azione giudiziaria. Tuttavia, l’esperimento della mediazione, anche se non andato a buon fine, costituisce comunque un passaggio necessario poiché essa è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Eredità e successioni: le controversie più frequenti e il ruolo della mediazione civile
Le dispute in materia di eredità e successione possono sorgere per una molteplicità di ragioni, spesso legate a divergenze interpretative sulle disposizioni testamentarie, alla determinazione delle quote di legittima o alla gestione dei beni ereditati in comproprietà tra coeredi. Questi conflitti, se non risolti tempestivamente, possono sfociare in lunghi procedimenti giudiziari, con conseguente aumento dei costi e deterioramento dei rapporti familiari.
Tra le controversie ereditarie più frequenti vi è la riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione della quota di legittima, che si verifica quando il testatore ha attribuito a uno o più beneficiari una parte dell’eredità eccedente i limiti stabiliti dalla legge, ledendo i diritti degli eredi legittimari. In questi casi, il soggetto leso può agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti, con il rischio di aprire un contenzioso che potrebbe protrarsi per anni. La mediazione consente di trovare una soluzione equilibrata, evitando il ricorso al giudice e garantendo una redistribuzione dei beni conforme agli interessi di tutte le parti.
Un’altra fonte di conflitto riguarda l’impugnazione del testamento olografo per falsità, quando uno degli eredi contesta l’autenticità delle volontà espresse dal de cuius. Tali contestazioni richiedono spesso complesse perizie grafologiche e accertamenti giudiziari, con il rischio di prolungare notevolmente i tempi della successione. In questi casi, la mediazione può offrire un terreno di confronto più rapido ed efficace, permettendo di giungere a un’intesa che eviti il contenzioso.
La collazione ereditaria, ossia l’obbligo per gli eredi di conferire nell’asse ereditario i beni ricevuti in donazione dal defunto in vita, rappresenta un ulteriore motivo di conflitto. Gli eredi possono avere opinioni divergenti sulla natura delle donazioni ricevute e sul valore attribuito ai beni, generando una situazione di stallo nella divisione dell’asse ereditario. Attraverso la mediazione, le parti possono trovare un accordo sulla determinazione del valore dei beni da conferire e sulle modalità di reintegrazione dell’asse ereditario.
Un altro tema particolarmente delicato è il divieto di patti successori, sancito dall’articolo 458 del Codice Civile, che impedisce agli eredi di stipulare accordi sulla futura successione di una persona ancora in vita. Nonostante questo divieto, è frequente che tra i familiari si formino intese informali o che vi siano aspettative che, alla morte del de cuius, sfociano in contestazioni legali.
La divisione ereditaria è spesso la questione più complessa da risolvere, specialmente quando il patrimonio ereditario comprende beni immobili o aziende di famiglia. In assenza di un accordo tra gli eredi, la divisione giudiziale può comportare la vendita forzata dei beni e la ripartizione del ricavato, soluzione che spesso non è gradita agli interessati.
In tutte queste ipotesi, la mediazione in materia di eredità e successione rappresenta uno strumento flessibile ed efficace, in grado di adattarsi alle esigenze specifiche delle parti e di preservare, per quanto possibile, i rapporti familiari. La possibilità di trovare soluzioni personalizzate, con il supporto di un legale, rende questa procedura preferibile rispetto alla rigidità della decisione giudiziale, spesso vissuta come un’imposizione da parte degli eredi.
I vantaggi della mediazione civile nelle successioni ereditarie
La mediazione civile applicata alle controversie in materia di eredità e successione offre una serie di vantaggi significativi rispetto al contenzioso giudiziario, sia in termini di tempi e costi, sia sotto il profilo della gestione dei rapporti familiari. A differenza del procedimento innanzi al giudice, che può protrarsi per anni e comportare oneri economici rilevanti, la mediazione consente di raggiungere un accordo in tempi più brevi, generalmente entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.
Sotto il profilo economico, i costi della mediazione sono generalmente inferiori rispetto a quelli di un giudizio ordinario. Le spese per l’avvio della procedura e per la partecipazione alle sessioni di mediazione sono contenute, se confrontate con le spese legali e peritali che un’azione giudiziaria potrebbe comportare. Inoltre, il compenso del mediatore è stabilito secondo parametri predeterminati e pubblicamente consultabili, garantendo trasparenza e prevedibilità dei costi.
Un ulteriore vantaggio della mediazione in materia di eredità e successione riguarda la possibilità di trovare soluzioni personalizzate e flessibili. Mentre il giudizio civile si conclude con una sentenza che impone una decisione alle parti, la mediazione lascia spazio alla negoziazione, consentendo di definire accordi che rispondano in modo più adeguato alle esigenze specifiche degli eredi.
Ad esempio, nella divisione ereditaria, le parti possono concordare modalità di assegnazione dei beni che tengano conto di legami affettivi, vincoli familiari o interessi economici, evitando così la vendita forzata e la distribuzione pro-quota imposta dal tribunale.
Anche sul piano della riservatezza il procedimento di mediazione presenta indubbi vantaggi. Mentre le cause giudiziarie sono soggette a pubblicità (il c.d. strepitus fori) e possono essere oggetto di consultazione nei registri del tribunale, la mediazione garantisce la tutela della privacy, permettendo agli eredi di discutere questioni patrimoniali e familiari senza esposizione pubblica. Questa caratteristica risulta particolarmente utile nei casi in cui il patrimonio ereditario comprenda aziende di famiglia, beni di valore storico o culturale, o situazioni delicate che potrebbero essere oggetto di speculazioni esterne.
Un ulteriore incentivo alla scelta della mediazione nelle controversie ereditarie è rappresentato dai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. In particolare, è riconosciuto un credito d’imposta alle parti che partecipano alla procedura di mediazione, commisurato alle spese sostenute per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione e per i compensi degli avvocati. Nello specifico, la parte ha diritto a un credito d’imposta fino a €600 sull’indennità pagata all’organismo in caso di accordo conciliativo, ridotto a €300 se la procedura si conclude senza accordo.
Infine, la mediazione consente di mantenere un certo grado di controllo sulla soluzione del conflitto. Nel processo ordinario, le parti sono vincolate alla decisione del giudice, che può non rispecchiare appieno le loro esigenze e aspettative. Nella mediazione, invece, gli eredi conservano la possibilità di accettare o rifiutare una determinata proposta, rendendo l’accordo più sostenibile nel tempo e riducendo il rischio di successivi contenziosi.
L’importanza dell’assistenza legale nella mediazione in materia di eredità e successione
Sebbene la mediazione civile sia un procedimento improntato alla flessibilità e al dialogo, la complessità delle questioni giuridiche in materia di eredità e successione rende fondamentale l’assistenza di un avvocato con competenze nel diritto successorio. Il ruolo del legale è determinante sin dalla fase preliminare, poiché consente di valutare la fondatezza delle proprie pretese e di impostare una strategia efficace per il raggiungimento di un accordo vantaggioso.
L’avvocato assiste il proprio cliente nella redazione dell’istanza di mediazione o nella gestione della risposta alla convocazione, tutelandone i diritti e guidandolo nelle trattative con gli altri coeredi. Durante il procedimento, il legale verifica la validità delle proposte conciliative, assicurandosi che l’accordo sia conforme alla normativa e risponda agli interessi della parte assistita.
Il nostro Studio offre assistenza legale qualificata in eredità e successione, per guidarti nel procedimento di mediazione. Contattaci per un primo confronto, senza impegno, per analizzare il tuo caso e individuare la strategia più efficace.

Avvocato Luca D’agostino, servizi legali in diritto civile a Roma. Focus su mediazione civile, eredità e successione

da Redazione | Mar 4, 2025 | Diritto civile
La vendita internazionale è la base per la crescita economica delle imprese e del Paese, consentendo ai soggetti commerciali di espandere il proprio mercato oltre i confini nazionali. Tuttavia, la natura transnazionale di tali operazioni rende necessario individuare con precisione quale normativa regoli il rapporto contrattuale tra le parti e quale sia l’autorità giurisdizionale competente in caso di controversia.
Nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea, le questioni relative alla legge applicabile ai contratti di vendita internazionale e alla competenza giurisdizionale sono disciplinate principalmente da tre fonti normative. Il Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) stabilisce i criteri per determinare la legge applicabile in assenza di una scelta esplicita delle parti. Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina la competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’Unione Europea.
Il presente contributo analizzerà sommariamente i criteri di individuazione della legge applicabile nei contratti di vendita internazionale, i principi che regolano la competenza giurisdizionale e le strategie contrattuali per prevenire controversie in ambito transfrontaliero.
Vendita internazionale di beni e determinazione della legge applicabile
Nell’ambito della vendita internazionale, la questione relativa alla legge applicabile al contratto riveste un ruolo di centrale importanza, in quanto disciplina gli obblighi reciproci delle parti e regola le conseguenze dell’eventuale inadempimento. L’ordinamento dell’Unione Europea fornisce una cornice normativa chiara per individuare la disciplina giuridica applicabile ai contratti transfrontalieri, evitando conflitti normativi che potrebbero pregiudicare la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
Il Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) rappresenta il principale strumento di diritto internazionale privato in materia contrattuale e sancisce il principio cardine della libertà di scelta delle parti. L’articolo 3 del Regolamento dispone che i contraenti possono designare la legge applicabile al loro rapporto contrattuale, purché tale scelta sia espressa o risulti con ragionevole certezza dai termini del contratto o dalle circostanze della fattispecie. La selezione della legge regolatrice è di fondamentale rilevanza nella vendita internazionale, in quanto consente alle parti di stabilire ex ante il quadro normativo di riferimento, evitando incertezze interpretative e possibili controversie sulla disciplina applicabile.
Qualora le parti non abbiano effettuato una scelta esplicita, il Regolamento Roma I stabilisce un criterio di collegamento oggettivo. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) prevede che, in assenza di una clausola di elezione della legge applicabile, il contratto di vendita internazionale di beni mobili sia regolato dalla legge dello Stato in cui il venditore ha la propria residenza abituale.
Tale disposizione si giustifica con la considerazione che il venditore è colui che esegue la prestazione caratteristica del contratto, ovvero la fornitura della merce. Per effetto di questa norma, un’impresa italiana che cede beni a un soggetto estero, in assenza di diversa pattuizione, vedrà regolato il proprio rapporto dalla legge italiana.
A tale disciplina si affianca la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG), adottata a Vienna nel 1980, la quale si applica automaticamente quando entrambe le parti contraenti hanno sede in Stati aderenti alla Convenzione, salvo espressa esclusione da parte delle stesse. La CISG regola vari aspetti della vendita internazionale, tra cui la formazione del contratto, gli obblighi del venditore e dell’acquirente, nonché le conseguenze dell’inadempimento.
Vendita internazionale di beni e competenza giurisdizionale
Nell’ambito della vendita internazionale, la frammentazione normativa tra i diversi ordinamenti giuridici potrebbe ingenerare incertezze sul riparto di competenza e sulla giurisdizione, con il rischio di lungaggini procedurali e difficoltà nell’esecuzione delle decisioni giudiziarie.
A tal fine, il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina la giurisdizione nelle controversie civili e commerciali all’interno dell’Unione Europea, fornendo criteri chiari e uniformi per determinare il foro competente nei contratti di vendita internazionale.
Secondo la regola generale sancita dall’articolo 4 del Regolamento Bruxelles I-bis, un soggetto domiciliato in uno Stato membro deve essere convenuto dinanzi ai tribunali dello Stato in cui ha il proprio domicilio. Tale principio garantisce la tutela della parte convenuta, imponendo al creditore di agire nel foro naturale del debitore.
Tuttavia, in materia contrattuale, il Regolamento prevede un’importante deroga alla regola generale, disciplinata dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che consente di convenire una parte anche dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Nel caso di un contratto di vendita internazionale di beni mobili, il luogo di esecuzione dell’obbligazione è quello in cui la merce è stata consegnata o avrebbe dovuto essere consegnata secondo il contratto.
La determinazione del luogo di consegna è dunque fondamentale per stabilire la competenza giurisdizionale in una controversia derivante dalla vendita internazionale. Se le parti non hanno previsto specifiche condizioni di consegna, il giudice dovrà accertare quale fosse il luogo effettivo di esecuzione della prestazione caratteristica.
Vendita internazionale di beni, clausola di foro e incidenza della clausola “franco magazzino”
Nel contesto della vendita internazionale, le parti contrattuali possono evitare incertezze in merito alla giurisdizione mediante l’inserimento di una clausola di elezione del foro, ossia una disposizione contrattuale che individua il giudice competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale.
Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) disciplina le condizioni di validità di tali pattuizioni, prevedendo che le parti possano convenire, in forma scritta o mediante una prassi consolidata, che una determinata autorità giurisdizionale abbia competenza esclusiva in caso di controversie contrattuali.
L’articolo 25 del Regolamento Bruxelles I-bis sancisce il principio secondo cui una clausola di scelta del foro è valida ed efficace se è stata stipulata: (i) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, (ii) secondo usi che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, oppure (iii) nell’ambito di relazioni commerciali precedenti che abbiano consolidato una consuetudine tra i contraenti. La previsione di una clausola di foro consente di evitare l’incertezza derivante dall’applicazione dei criteri generali di competenza giurisdizionale e permette alle imprese di pianificare con maggiore sicurezza la gestione del rischio legale nella vendita internazionale.
Un ulteriore elemento di rilievo nella vendita internazionale riguarda la clausola “franco magazzino” la quale incide direttamente sulla determinazione del foro competente. Con tale clausola, il venditore si libera dall’obbligo di consegna nel momento in cui mette la merce a disposizione dell’acquirente presso il proprio magazzino o stabilimento. Ne consegue che il rischio e la responsabilità per il trasporto ricadono interamente sull’acquirente, il quale si assume l’onere di provvedere al ritiro della merce e alla sua spedizione.
Dal punto di vista della competenza giurisdizionale, la clausola “franco magazzino” ha una rilevanza determinante, poiché il luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale coincide con la sede del venditore. In base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del Regolamento Bruxelles I-bis, il giudice competente nelle controversie relative alla vendita internazionale è quello del luogo in cui la merce è stata consegnata o avrebbe dovuto essere consegnata secondo il contratto.
Pertanto, laddove il contratto preveda una consegna “franco magazzino”, è ragionevole ritenere che la competenza spetta al tribunale dello Stato in cui il venditore ha la propria sede, in quanto la prestazione caratteristica del contratto si considera eseguita nel momento in cui la merce viene resa disponibile presso il suo stabilimento.
La combinazione della clausola di foro esclusivo e della clausola “franco magazzino” rappresenta un efficace strumento di tutela per il venditore che operi nella vendita internazionale, in quanto consente di rafforzare la propria posizione giuridica in caso di contenzioso con il compratore. La previsione congiunta di entrambe le clausole nei documenti contrattuali e commerciali permette di radicare la giurisdizione nel paese del venditore e di semplificare l’eventuale azione di recupero del credito.
Vendita internazionale di beni e tutela del creditore in caso di inadempimento
Nell’ambito della vendita internazionale, il mancato pagamento del corrispettivo da parte del compratore rappresenta una delle problematiche più ricorrenti per le imprese che operano nel commercio transfrontaliero.
La Convenzione di Vienna del 1980 (CISG) disciplina in modo specifico le conseguenze dell’inadempimento contrattuale nella vendita internazionale. In particolare, ai sensi dell’articolo 53, l’acquirente ha l’obbligo di pagare il prezzo pattuito e di accettare la consegna della merce nei termini previsti dal contratto. Qualora il compratore ometta di adempiere all’obbligo di pagamento, il venditore può avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli 61 e seguenti, che comprendono la richiesta di esecuzione forzata del pagamento, la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno. Tuttavia, la CISG non disciplina gli aspetti procedurali relativi all’azione di recupero del credito, i quali sono regolati dal diritto nazionale dello Stato competente.
Uno degli strumenti più efficaci per ottenere rapidamente il pagamento del credito è il procedimento per decreto ingiuntivo, che consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo senza dover intraprendere un’azione ordinaria di cognizione. In base all’articolo 633 del codice di procedura civile italiano, il decreto ingiuntivo può essere richiesto quando il credito risulta fondato su prova scritta, quale una fattura, un ordine di acquisto, un documento di trasporto o una conferma d’ordine sottoscritta.
Un’ulteriore tutela, particolarmente utile per rapporti transfrontalieri UE, è offerta dal Regolamento (CE) n. 1896/2006, che ha introdotto il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, applicabile nelle controversie transfrontaliere tra parti domiciliate in Stati membri diversi. Tale strumento consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo europeo senza dover avviare procedimenti giurisdizionali in più ordinamenti, garantendo una maggiore rapidità ed efficienza nell’azione di recupero del credito nella vendita internazionale.
La tutela legale nella vendita internazionale
L’individuazione della legge applicabile e della competenza giurisdizionale in un contratto di vendita internazionale è un elemento strategico di centrale importanza per facilitare l’eventuale azione di recupero del credito in caso di mancato pagamento da parte del compratore estero.
Il nostro Studio Legale è a disposizione per assistere imprese e operatori commerciali nei rapporti di vendita internazionale, fornendo un supporto altamente qualificato nella redazione della documentazione contrattuale e nella gestione delle controversie transfrontaliere. Offriamo un servizio di consulenza strategica per mitigare i rischi legali, strutturare accordi che garantiscano la massima tutela e, laddove possibile, radicare la giurisdizione in Italia e la competenza dinanzi ai tribunali nazionali.
Assistiamo i nostri clienti sia nella fase preventiva di negoziazione e stipula dei contratti, sia nella fase patologica del rapporto contrattuale, affiancandoli nelle azioni di recupero del credito e nelle strategie di tutela giudiziaria.