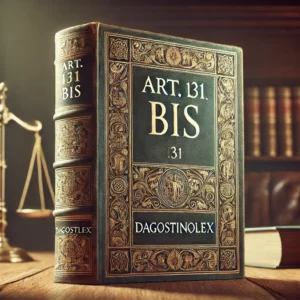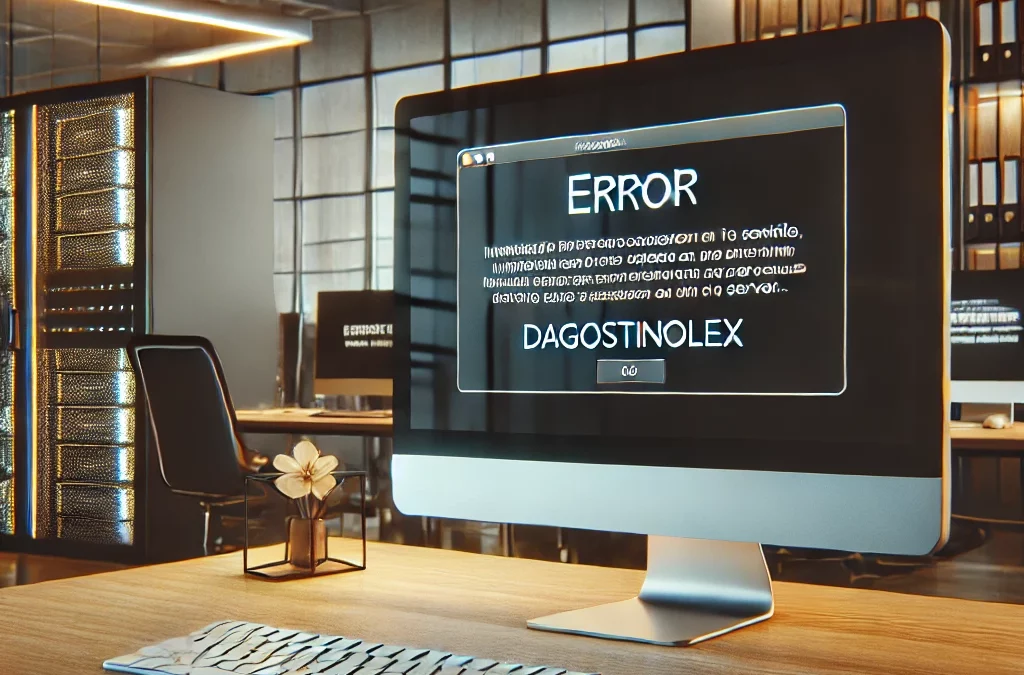da Redazione | Dic 28, 2024 | Notizie e Aggiornamenti Legislativi, Diritto Penale
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 di riforma del Codice della Strada segna un cambiamento significativo nell’ambito della circolazione stradale, introducendo nuove disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità degli utenti della strada. Questo intervento legislativo, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, mira a rafforzare il sistema sanzionatorio e a promuovere un approccio più rigoroso alla prevenzione degli incidenti stradali.
Tuttavia, tale riforma del Codice della Strada ha già suscitato ampie discussioni, lasciando adito a molti dubbi sia sul piano applicativo che su quello sostanziale. Secondo alcuni, le nuove disposizioni presentano profili di eccessivo rigore. Sebbene l’obiettivo dichiarato sia quello di incrementare la sicurezza sulle strade, non manca chi ritiene che alcune delle novità possano risultare sproporzionate rispetto alle situazioni che intendono disciplinare.
L’intero impianto normativo si fonda su un concetto chiave: incrementare il livello di sicurezza sulle strade italiane mediante strumenti più efficaci e sanzioni più incisive. In particolare, le modifiche al Codice della Strada intervengono su una vasta gamma di aspetti, che spaziano dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, alle nuove regole per i neopatentati, fino a discipline specifiche per la micromobilità e l’utilizzo dei monopattini elettrici.
In questo articolo ci proponiamo di offrire una panoramica ragionata delle principali novità che riguardano la guida in stato d’ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Codice della Strada e guida in stato di ebbrezza: obblighi, dispositivi e sanzioni
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 di riforma del Codice della Strada ha inasprito le misure volte a contrastare la guida in stato di ebbrezza e il consumo di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti.
Una delle misure più significative è l’introduzione obbligatoria del dispositivo alcolock, che impedisce l’accensione del veicolo qualora il conducente presenti un tasso alcolemico superiore allo zero. Questo dispositivo, già ampiamente utilizzato in altri ordinamenti europei, viene ora prescritto anche dal Codice della Strada italiano per i conducenti recidivi, ossia coloro che sono stati condannati per guida in stato di ebbrezza.
L’obbligatorietà dell’alcolock si accompagna all’inserimento di codici unionali sulla patente di guida, come il “Codice 68” (divieto di consumo di alcol) e il “Codice 69” (obbligo di guida di veicoli dotati di alcolock). Tali prescrizioni restano valide per un minimo di due anni nei casi meno gravi e di tre anni per le infrazioni più gravi, salvo indicazioni diverse della commissione medica.
La mancata osservanza di queste disposizioni comporta sanzioni molto severe. Le pene previste per i reati di guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo per i conducenti obbligati all’uso dell’alcolock e raddoppiate in caso di manomissione o rimozione del dispositivo. Il Codice della Strada prevede, inoltre, la revisione della patente in tutti i casi di manomissione, a conferma della volontà del legislatore di adottare un approccio zero-tolerance nei confronti di tali comportamenti. La revisione è disposta dal Prefetto ai sensi dell’articolo 128, con l’obiettivo di garantire l’adeguamento delle patenti alle prescrizioni imposte.
In generale, resta invariata la classificazione delle violazioni in base al tasso alcolemico rilevato, articolata in tre fasce: da 0,5 a 0,8 g/l, da 0,8 a 1,5 g/l, e oltre 1,5 g/l. Tuttavia, la riforma del Codice della Strada ha aumentato le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per ciascuna fascia, aggiungendo un ulteriore aggravio per i conducenti obbligati all’alcolock. Le multe sono aumentate di un terzo per chi è soggetto a tale obbligo, mentre il mancato rispetto delle prescrizioni o la manomissione del dispositivo comportano un raddoppio delle sanzioni e l’immediata revisione della patente ai sensi dell’articolo 128 del Codice della Strada.
Un altro elemento di continuità riguarda l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti etilometrici in caso di sospetto da parte degli organi di polizia. La riforma non ha modificato le modalità operative dei controlli, che continuano a prevedere l’utilizzo di strumenti certificati per la rilevazione del tasso alcolemico. Restano invariate anche le conseguenze per il rifiuto di sottoporsi al test, assimilata quoad poneam alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 7, Codice della Strada).
Permane l’obbligo per i conducenti professionali e per i neopatentati di mantenere un tasso alcolemico pari a zero, senza alcuna tolleranza. Questo principio, introdotto nelle precedenti riforme del Codice della Strada, è stato confermato e ulteriormente rafforzato attraverso l’incremento delle sanzioni pecuniarie e delle pene accessorie per le violazioni commesse da queste categorie di conducenti.
Codice della Strada e guida sotto l’effetto di stupefacenti: obblighi e sanzioni
Oltre alle disposizioni relative all’alcol, la riforma introduce cambiamenti significativi per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, intervenendo sull’articolo 187 del Codice della Strada. La nuova normativa elimina il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica” del conducente, basandosi esclusivamente sulla positività agli accertamenti tossicologici.
Questa modifica, volta a semplificare l’applicazione delle sanzioni, ha suscitato critiche in quanto potrebbe portare a contestazioni fondate su dati meramente oggettivi, senza una valutazione completa dello stato del conducente. La revoca della patente è automatica per chi risulta positivo ai test, senza la necessità di dimostrare un’effettiva compromissione della capacità di guida.
La riforma introduce, inoltre, una procedura dettagliata per gli accertamenti tossicologici, basata sull’utilizzo di tecniche non invasive, come il prelievo di campioni dal cavo orale. Gli esami devono essere effettuati in laboratori certificati, garantendo così la massima affidabilità dei risultati. In caso di esito positivo al test preliminare, gli organi di polizia possono disporre il ritiro immediato della patente, vietando al conducente di continuare a guidare per un periodo massimo di dieci giorni, in attesa dei risultati definitivi.
Non mancano, infine, le misure accessorie. Il Prefetto può disporre la sospensione cautelare della patente e l’obbligo di visita medica entro sessanta giorni. Qualora l’esito della visita confermi l’idoneità alla guida, la validità della patente sarà limitata a un anno, con possibilità di rinnovo per periodi successivi di tre e cinque anni. Nei casi di inidoneità, invece, è prevista la revoca definitiva della patente.
Questa disciplina, pur riconoscendosi come rigorosa e innovativa, solleva interrogativi circa la proporzionalità delle pene e l’efficacia pratica delle misure adottate. Sebbene il legislatore abbia inteso rafforzare la prevenzione, non sono mancati rilievi critici, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sulle libertà individuali e la gestione delle contestazioni. Resta da vedere se queste disposizioni contribuiranno effettivamente a una riduzione degli incidenti stradali, come auspicato, o se sarà necessario un ulteriore intervento normativo per correggere eventuali criticità emerse nella fase applicativa.
Codice della Strada e sostanze stupefacenti: accertamenti tossicologici e revoca della patente
La riforma del Codice della Strada introdotta dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 apporta significative modifiche alle disposizioni riguardanti la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento all’articolo 187 Codice della Strada. Come premesso, la nuova normativa si distingue per la semplificazione del quadro sanzionatorio e per l’introduzione di procedure più stringenti e dettagliate volte ad accertare il consumo di tali sostanze da parte dei conducenti. Il legislatore, infatti, ha scelto di eliminare il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica”, prevedendo che la positività agli accertamenti tossicologici sia sufficiente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
In particolare, la nuova disciplina introduce una procedura di accertamento articolata in più fasi. Gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti a test qualitativi preliminari non invasivi, eseguibili anche tramite apparecchi portatili. Qualora questi test diano esito positivo, o qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti, è previsto il prelievo di campioni dal cavo orale.
Gli esami successivi devono essere condotti esclusivamente in laboratori certificati, conformi agli standard forensi, per garantire la validità e l’affidabilità dei risultati. Questa attenzione alla qualità e alla sicurezza degli accertamenti riflette la necessità di tutelare i diritti del conducente, pur in un contesto di rigore crescente.
La riforma introduce anche un’importante novità in caso di accertamenti positivi. Gli organi di polizia possono disporre il ritiro immediato della patente, che rimarrà sospesa per un massimo di dieci giorni, in attesa degli esiti definitivi degli accertamenti. Durante questo periodo, è vietato condurre veicoli, e il mezzo sarà trasferito a spese del conducente presso una località indicata o un’autorimessa. Qualora non sia possibile completare gli accertamenti, il Prefetto dispone comunque la sospensione cautelare della patente e impone al conducente di sottoporsi a una visita medica entro sessanta giorni.
Le sanzioni previste per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono severe e comprendono la revoca automatica della patente in caso di esito negativo degli accertamenti medici. In tali circostanze, il conducente non potrà richiedere una nuova patente prima di tre anni. Per i conducenti che risultano idonei alla guida, invece, la patente avrà una validità limitata a un anno, con successive estensioni per periodi di tre o cinque anni.
La disciplina è particolarmente rigorosa per i conducenti minori di ventuno anni, che non potranno conseguire la patente fino al compimento del ventiquattresimo anno di età qualora abbiano commesso reati legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Queste disposizioni, pur rispondendo all’esigenza di garantire maggiore sicurezza sulle strade, sollevano dubbi in merito alla loro rigidità e alla proporzionalità delle sanzioni. In particolare, la possibilità che la sola positività ai test tossicologici sia sufficiente per l’applicazione delle pene pone interrogativi sul rispetto dei principi di tutela delle libertà individuali e di giustizia sostanziale.
Modifiche al codice penale: omicidio e lesioni stradali aggravati dalla guida sotto l’effetto di stupefacenti
Con la Legge 25 novembre 2024 n. 177, il legislatore è intervenuto sul testo degli articoli 589-bis e 590-bis c.p., relativi ai reati di omicidio e lesioni personali stradali, per adeguarli alle modifiche apportate all’articolo 187 del Codice della Strada. Quest’ultimo, infatti, non contiene più alcun riferimento allo stato di “alterazione psicofisica” conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, eliminando tale requisito per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Nel nuovo quadro normativo, per configurare le aggravanti previste dai commi 2 degli articoli 589-bis e 590-bis c.p., è necessario provare che il conducente fosse in uno stato di alterazione psicofisica effettiva, determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo implica che, a differenza di quanto richiesto per l’applicazione delle sanzioni amministrative, la mera positività agli accertamenti tossicologici non è sufficiente per contestare l’aggravante penale: occorre dimostrare l’effettiva alterazione delle capacità psicofisiche del conducente al momento del sinistro.
Al contrario, per l’applicazione delle sanzioni amministrative, l’accertamento della positività a sostanze stupefacenti è di per sè sufficiente, indipendentemente dall’effettivo stato di alterazione. In definitiva, la dimostrazione del concreto stato di alterazione psicofisica rileva soltanto per la contestazione della circostanza aggravante nei casi di omicidio o lesioni stradali, mentre non è necessaria per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Questa distinzione tra sanzioni amministrative e aggravanti penali mira a bilanciare esigenze preventive e garanzie costituzionali, ma solleva anche diversi dubbi.
Profili di incostituzionalità nella riforma del Codice della Strada
Invero, la Legge 25 novembre 2024 n. 177, che ha riformato il Codice della Strada, ha suscitato un ampio dibattito in dottrina riguardo a possibili profili di incostituzionalità. Le critiche si concentrano su alcune disposizioni che, secondo i detrattori, violano principi costituzionali fondamentali quali l’uguaglianza, la ragionevolezza delle norme, la tutela delle libertà individuali e il diritto al lavoro.
Un primo aspetto riguarda il principio di uguaglianza, sancito dall’articolo 3 della Costituzione. L’imposizione automatica del dispositivo alcolock per i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza non consente di valutare caso per caso la gravità dell’infrazione o le circostanze personali del trasgressore. La rigidità della norma potrebbe comportare un trattamento non proporzionato tra soggetti che, pur trovandosi in situazioni personali differenti, subiscono le medesime sanzioni, in contrasto con il principio di equità.
Altre critiche si concentrano sul principio di ragionevolezza, anch’esso tutelato dall’articolo 3. La revoca automatica della patente per positività ai test tossicologici, senza accertare uno stato di alterazione psicofisica o un’effettiva pericolosità alla guida, introduce una presunzione assoluta che alcuni ritengono eccessiva. La Corte Costituzionale ha in passato ribadito che le sanzioni devono essere proporzionate e collegate a comportamenti concreti, per evitare violazioni del principio di giustizia sostanziale.
La riforma solleva dubbi anche in relazione alla libertà personale, garantita dall’articolo 13 della Costituzione. Sebbene le misure come la revoca della patente o il ritiro immediato non configurino una privazione della libertà in senso stretto, esse incidono significativamente sull’autodeterminazione individuale, soprattutto se applicate in modo automatico senza possibilità di difesa preventiva.
Un ulteriore elemento di criticità riguarda il diritto al lavoro, tutelato dall’articolo 4 della Costituzione. La revoca della patente può avere conseguenze particolarmente gravi per i lavoratori che utilizzano il veicolo come strumento essenziale per la propria attività professionale. L’assenza di deroghe per specifiche categorie di conducenti potrebbe determinare una compressione del diritto al lavoro, con ripercussioni economiche e sociali rilevanti.
Ricordiamo peraltro che la Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata (v. sentenza n. 52/2024) dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del Codice della Strada che sancivano automatismi applicativi. Ciò lascia supporre che, anche le novellate disposizioni, si espongono a censure di incostituzionalità.
In conclusione, sebbene la riforma del Codice della Strada miri a rafforzare la sicurezza stradale attraverso misure innovative e severe, essa pone interrogativi sul bilanciamento tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Una corretta applicazione delle norme, accompagnata da eventuali interventi correttivi del legislatore o della Corte Costituzionale, potrebbe essere necessaria per evitare tensioni con i principi costituzionali, garantendo così un’efficace protezione degli utenti della strada e il rispetto delle libertà individuali.
Neopatentati e il Codice della Strada: nuove restrizioni e obblighi formativi
La riforma introdotta dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 dedica particolare attenzione alla categoria dei neopatentati, modificando in modo significativo l’articolo 117 del Codice della Strada. L’obiettivo del legislatore è di aumentare la sicurezza stradale attraverso l’imposizione di limitazioni più stringenti e l’introduzione di obblighi formativi che mirano a garantire una maggiore consapevolezza e preparazione dei conducenti più giovani. Queste disposizioni, entrate in vigore il 14 dicembre 2024, rispondono all’esigenza di contrastare la frequenza degli incidenti stradali che coinvolgono conducenti inesperti.
Tra le novità principali, spiccano i nuovi limiti di potenza per i veicoli guidabili dai neopatentati. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, è vietata la guida di veicoli con una potenza specifica superiore a 75 kW per tonnellata, salvo alcune eccezioni per i veicoli elettrici o ibridi plug-in, per i quali il limite è fissato a 105 kW. Questa limitazione si pone l’obiettivo di ridurre il rischio di condotte di guida pericolose, evitando che i neopatentati possano mettersi alla guida di mezzi particolarmente potenti o difficili da gestire.
Un altro aspetto innovativo della riforma riguarda l’obbligo di effettuare esercitazioni pratiche specifiche, come previsto dall’articolo 122, comma 5-bis del Codice della Strada. L’aspirante conducente dovrà svolgere esercitazioni su autostrade, strade extraurbane principali e in condizioni di visione notturna. Tali esercitazioni, che dovranno essere certificate da una scuola guida accreditata, costituiscono un prerequisito essenziale per ottenere l’idoneità alla guida. Questa misura mira a preparare i neopatentati a gestire situazioni di traffico complesse e condizioni di guida impegnative, riducendo così il rischio di incidenti.
La riforma introduce anche una maggiore severità nelle sanzioni per i neopatentati che violano le norme del Codice della Strada. In caso di trasgressioni gravi, come il superamento dei limiti di velocità o la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, le pene accessorie, quali la sospensione della patente, risultano aggravate rispetto a quelle previste per i conducenti più esperti. Questa differenziazione, basata sul principio di maggiore responsabilità proporzionale all’esperienza di guida, intende agire come deterrente per comportamenti pericolosi.
Le nuove disposizioni per i neopatentati, pur essendo accolte positivamente per il loro intento di promuovere una guida più sicura, non mancano di suscitare critiche. In particolare, alcuni osservatori hanno evidenziato che l’obbligo di esercitazioni pratiche potrebbe rappresentare un onere economico significativo per le famiglie, penalizzando soprattutto chi dispone di risorse limitate. Inoltre, i limiti di potenza sono stati talvolta considerati troppo restrittivi, limitando la possibilità di scegliere veicoli adeguati alle esigenze quotidiane, come l’utilizzo familiare. Tuttavia, il legislatore sembra aver adottato un approccio prudenziale, valutando prioritario l’interesse collettivo alla sicurezza rispetto a eventuali difficoltà individuali.
Conclusioni: un Codice della Strada più severo, ma con margini di criticità
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 di riforma del Codice della Strada, ha inasprito le sanzioni per promuovere una maggiore sicurezza stradale. Con l’introduzione di nuove regole sulla guida in stato di ebbrezza, sugli accertamenti tossicologici, sulle limitazioni per i neopatentati, il legislatore ha inteso adattare la normativa alle esigenze di un sistema in costante evoluzione.
Le modifiche apportate evidenziano un approccio improntato al rigore e alla prevenzione. Si tratta, tuttavia, di una riforma che non va esente da criticità. In particolare, alcune delle nuove disposizioni sono state giudicate da più parti eccessivamente rigide, sollevando dubbi sulla proporzionalità delle sanzioni e sull’impatto sociale di alcune regole. Inoltre, il successo della riforma dipenderà in larga misura dalla capacità di garantire una corretta informazione e sensibilizzazione degli utenti della strada.
In conclusione, il nuovo Codice della Strada segna un passaggio significativo verso una mobilità più sicura e responsabile, ma richiede una riflessione costante per bilanciare rigore e proporzionalità. Gli utenti della strada sono chiamati a un ruolo attivo nel recepire e rispettare le nuove regole, contribuendo così a rendere le strade italiane un luogo più sicuro per tutti.
Per qualsiasi chiarimento o per ricevere assistenza legale sul Codice della Strada o su sinistri, lo Studio Legale D’Agostino è a disposizione per fornire consulenze personalizzate, affiancando gli utenti nella comprensione e nell’applicazione delle normative, tutelando i loro diritti con competenza e professionalità.

Codice della Strada: assistenza legale dello Studio Legale D’Agostino per casi di incidenti stradali, alcol e stupefacenti a Roma.

da Redazione | Dic 12, 2024 | Diritto Penale
La particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, costituisce una causa di non punibilità ispirata ai principi di proporzionalità, offensività e sussidiarietà del diritto penale. Introdotto con il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e successivamente riformato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), l’istituto mira a escludere la punibilità di condotte che, pur configurando astrattamente un reato, presentano un grado minimo di offensività.
L’obiettivo principale è deflattivo, essendo volto a razionalizzare il carico giudiziario concentrando l’intervento penale sui casi realmente gravi e meritevoli di sanzione. Tale approccio, ispirato alla concezione gradualistica del reato, si traduce in un’applicazione del diritto penale come extrema ratio.
In questo contesto, il ruolo dell’avvocato è di centrale importanza. Grazie alla sua competenza, l’avvocato può evidenziare, sia al pubblico ministero sia al giudice, gli elementi che dimostrano la particolare tenuità dell’offesa, promuovendo così provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento. L’intervento dell’avvocato è essenziale per assicurare che il caso concreto venga analizzato nella sua specificità, valorizzando tutte le circostanze che possono condurre all’applicazione di quest’istituto.
L’obiettivo del presente articolo è fornire una panoramica esaustiva della disciplina relativa alla tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), analizzandone i principi fondamentali, i presupposti di applicazione e le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia. Inoltre, saranno approfonditi i più rilevanti orientamenti giurisprudenziali e i profili processuali legati all’istituto.
L’intento è quello di evidenziare non solo le peculiarità normative dell’art. 131-bis, ma anche le sue implicazioni pratiche per il difensore, che svolge un ruolo determinante nel garantire una corretta applicazione della norma a tutela degli interessi del proprio assistito.
L’art. 131-bis, nella sua originaria formulazione, prevedeva l’applicabilità della causa di non punibilità ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta. La Riforma Cartabia ha ampliato tale ambito di applicazione, spostando l’attenzione sul limite minimo della pena, ora fissato a due anni.
Ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dal rilievo attribuito alla condotta susseguente al reato, considerata dal legislatore un ulteriore criterio per la valutazione della tenuità dell’offesa. Questi interventi normativi riflettono una concezione più equilibrata del diritto penale, che valorizza la specificità del caso concreto.
La tenuità del fatto (art. 131-bis): nozione e principi generali
L’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è il precipitato di un approccio moderno al diritto penale, che mira a modulare l’intervento repressivo in base alla concreta offensività della condotta. Esso rappresenta una causa di non punibilità che si applica quando, pur essendo integrati gli elementi costitutivi del reato, l’offesa risulta di minima gravità, sia per le modalità della condotta sia per l’esiguità del danno o del pericolo, come previsto dall’art. 133, primo comma, del codice penale.
La particolare tenuità del fatto consente, in sostanza, di escludere la punibilità per condotte che, pur essendo astrattamente rilevanti, non raggiungono una soglia di gravità tale da giustificare l’irrogazione di una pena.
In origine, l’art. 131-bis c.p. limitava l’applicabilità dell’istituto ai reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, oppure con pena pecuniaria, sola o congiunta. Tuttavia, con la Riforma Cartabia, il legislatore ha rimodulato la portata della norma, introducendo il criterio del minimo edittale. Attualmente, la causa di non punibilità può essere applicata ai reati puniti con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.
Di particolare rilievo è anche la natura giuridica dell’istituto, su cui si sono a lungo confrontate dottrina e giurisprudenza. Mentre una parte della dottrina lo considerava una condizione dell’azione penale, l’orientamento prevalente ne ha riconosciuto la natura sostanziale, qualificandolo come una vera e propria causa di non punibilità.
Questo inquadramento è stato ribadito dalla giurisprudenza, che ha sottolineato come l’applicazione della norma richieda un accertamento rigoroso sia sulla commissione del fatto sia sulla sussistenza dell’elemento soggettivo.
In questo quadro, il ruolo dell’avvocato emerge come centrale. Egli è chiamato a dimostrare l’insussistenza di comportamenti abituali e a valorizzare gli aspetti della condotta che possano qualificare l’offesa come di particolare tenuità. Attraverso un’analisi dettagliata del caso concreto, il difensore contribuisce a garantire che la norma venga applicata in modo coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento, rappresentando un fondamentale baluardo contro l’eccessiva criminalizzazione di fatti di minima rilevanza.
Ambito di applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis)
L’ambito di applicazione della tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stato delineato dal legislatore tenendo conto sia della tipologia dei reati sia delle circostanze che possono escludere la configurabilità della causa di non punibilità.
La valutazione circa la particolare tenuità del fatto è rimessa al potere discrezionale del giudice, che deve verificare, in relazione al caso concreto, se le modalità della condotta e l’entità del danno o del pericolo siano tali da rendere l’offesa particolarmente tenue. Questo giudizio richiede un esame attento delle modalità esecutive del fatto, come il luogo, il tempo e i mezzi impiegati, nonché il grado della colpevolezza. Tuttavia, la norma esclude l’applicabilità dell’istituto in presenza di condotte particolarmente gravi, come quelle caratterizzate da crudeltà, sevizie o approfittamento di condizioni di minorata difesa della vittima.
L’istituto della particolare tenuità del fatto trova applicazione non solo nei reati consumati, ma anche in quelli tentati, purché sia accertata l’esiguità dell’offesa nel caso in cui il reato avesse raggiunto il compimento. Analogamente, i reati di pericolo astratto o presunto non sono esclusi a priori dall’ambito di applicazione, poiché anche in tali ipotesi è possibile riscontrare una minima offensività dell’azione. Tuttavia, la norma non si estende ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace, per i quali permangono discipline specifiche, sebbene su questo punto vi siano state interpretazioni divergenti in giurisprudenza.
Il ruolo dell’avvocato si dimostra centrale nella valorizzazione degli elementi che possono condurre all’applicazione della tenuità del fatto (art. 131-bis). Attraverso una puntuale rappresentazione delle peculiarità del caso concreto, il difensore può agevolare una decisione favorevole, dimostrando che l’offesa risulta effettivamente priva di un significativo disvalore penale. L’analisi attenta e approfondita di tutte le circostanze, comprese quelle relative all’eventuale non abitualità del comportamento, consente al giudice di valutare con maggiore precisione l’idoneità del fatto ad essere considerato di particolare tenuità.
Reati esclusi dall’applicazione della tenuità del fatto (art. 131-bis)
Nonostante la sua ampia applicabilità, l’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) prevede importanti limitazioni, escludendo la possibilità di dichiarare la non punibilità per una serie di delitti specificamente individuati dalla legge. Queste esclusioni riflettono la volontà del legislatore di riservare l’applicazione della norma a condotte realmente prive di significativa offensività, escludendo quei comportamenti considerati ex lege intrinsecamente gravi o lesivi di interessi fondamentali.
In primo luogo, l’art. 131-bis c.p. non si applica ai delitti puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, se commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tale previsione risponde alla necessità di contrastare con fermezza episodi di violenza o disordini in un contesto che coinvolge un’ampia partecipazione pubblica.
Sono altresì esclusi i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis c.p., quando commessi nei confronti di pubblici ufficiali o agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni. La norma si estende anche al delitto di cui all’art. 343 c.p., rafforzando la tutela dell’autorità pubblica contro comportamenti che ne minano la credibilità e il regolare funzionamento.
Un ulteriore gruppo di esclusioni riguarda delitti particolarmente gravi, sia consumati che tentati, tra cui figurano quelli previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319 e seguenti, che disciplinano reati contro la pubblica amministrazione, come la corruzione e la concussione, nonché delitti contro la persona aggravati (artt. 582, aggravato dagli artt. 576 e 577, e 583-bis). Sono inclusi anche reati sessuali (artt. 609-bis e seguenti) e delitti contro il patrimonio aggravati, come la rapina (art. 628, comma 3) e l’estorsione (art. 629 c.p.).
Rientrano nelle esclusioni i delitti previsti dall’art. 19, quinto comma, della legge n. 194/1978, e dall’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, tranne quelli specificati al comma 5 dello stesso articolo, così come i delitti di rilevanza finanziaria disciplinati dagli articoli 184 e 185 del D.Lgs. n. 58/1998. Infine, non è applicabile ai reati di contraffazione previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633/1941, salvo per le fattispecie più lievi di cui all’art. 171 della medesima legge.
Queste esclusioni confermano l’intento del legislatore di riservare l’applicazione dell’art. 131-bis ai casi in cui il disvalore del fatto sia effettivamente lieve, escludendo reati che, per la loro gravità intrinseca o per l’interesse protetto, richiedono una risposta penale più rigorosa. Anche in questo contesto, il ruolo dell’avvocato è essenziale per valutare con precisione l’applicabilità dell’istituto e tutelare al meglio gli interessi del proprio assistito, assicurando che ogni esclusione sia interpretata in coerenza con i principi fondamentali del diritto penale.
Le novità introdotte dalla Riforma Cartabia e la tenuità del fatto (art. 131-bis)
La Riforma Cartabia ha apportato modifiche significative all’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), modificandone l’ambito di applicazione e introducendo nuovi criteri di valutazione. Una delle innovazioni principali riguarda il limite edittale della pena: la norma, nella sua versione originaria, prevedeva l’applicabilità dell’istituto ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. La riforma, intervenendo sull’art. 131-bis, ha sostituito tale parametro con quello del minimo edittale, fissandolo a due anni di reclusione.
Un altro elemento innovativo introdotto dalla riforma riguarda il rilievo attribuito alla condotta susseguente al reato. Il legislatore ha espressamente previsto che il giudice debba tener conto anche del comportamento dell’autore successivo alla commissione del fatto, come ulteriore criterio per valutare la tenuità dell’offesa.
Sebbene il testo normativo non specifichi quali condotte post delictum debbano essere considerate, tale indeterminatezza consente al giudice di apprezzare una vasta gamma di elementi, quali eventuali iniziative riparatorie, il risarcimento del danno o l’impegno a limitare le conseguenze pregiudizievoli del reato.
La riforma ha dunque abbandonato una visione statica della norma, che in passato correlava l’esiguità dell’offesa unicamente alle modalità della condotta e all’entità del danno o del pericolo, valorizzando invece un approccio globale e dinamico. Il riferimento alla condotta susseguente sottolinea la necessità di valutare il fatto nel suo complesso, tenendo conto non solo delle circostanze concomitanti al reato, ma anche delle scelte e dei comportamenti adottati dall’autore in seguito.
Alcuni orientamenti giurisprudenziali sulla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis)
La giurisprudenza ha svolto un ruolo determinante nell’interpretazione e nell’applicazione dell’istituto della tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), contribuendo a delinearne i confini e a risolvere le principali questioni interpretative. Uno degli aspetti più dibattuti ha riguardato la natura giuridica dell’istituto.
Dopo un iniziale contrasto tra chi lo considerava una condizione dell’azione penale e chi, invece, lo qualificava come una causa di non punibilità, l’orientamento prevalente ha optato per questa seconda tesi, evidenziando il carattere sostanziale della norma. Tale impostazione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito la necessità di un accertamento rigoroso sulla sussistenza del fatto, dell’elemento soggettivo e delle condizioni previste dall’art. 131-bis.
Un’altra questione significativa affrontata dalla giurisprudenza riguarda l’applicabilità dell’istituto ai reati continuati o abituali. Mentre alcuni orientamenti escludono l’applicazione della norma in presenza di condotte reiterate o seriali, ritenendole espressione di un comportamento abituale ostativo al riconoscimento della tenuità del fatto, altri riconoscono la possibilità di valutare l’esiguità delle singole condotte, purché ciascun episodio sia analizzato autonomamente.
Tali divergenze testimoniano la complessità dell’istituto e l’importanza di un’interpretazione caso per caso, che tenga conto delle circostanze concrete e della ratio sottesa alla norma.
La giurisprudenza ha anche chiarito che la particolare tenuità dell’offesa non può essere applicata a reati connotati da una gravità intrinseca o da modalità particolarmente lesive, come i reati commessi con crudeltà, per motivi abietti o con l’uso di sevizie. Inoltre, la norma non si estende ai reati che, per loro natura, presuppongono una reiterazione di condotte, come il delitto di abusivo esercizio di una professione, in quanto configurano comportamenti abituali incompatibili con i presupposti dell’art. 131-bis.
Particolare attenzione è stata riservata ai profili applicativi nei casi di reati di pericolo astratto. In queste ipotesi, la giurisprudenza ha riconosciuto che anche in presenza di una fattispecie astrattamente offensiva, l’esiguità del danno o del pericolo concreto può giustificare l’applicazione della norma. Questo orientamento riflette la volontà di valorizzare il principio di offensività, attribuendo rilievo alla concreta lesione o minaccia del bene giuridico tutelato.
Profili processuali della tenuità del fatto (art. 131-bis)
I profili processuali dell’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) sono fondamentali, poiché la norma si presta a essere rilevata d’ufficio in qualsiasi fase del procedimento penale.
Tale peculiarità ne fa uno strumento particolarmente versatile, applicabile sia nella fase delle indagini preliminari che durante il giudizio, fino all’appello. La possibilità di dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto è prevista, infatti, non solo in sede di archiviazione, ma anche attraverso provvedimenti come la sentenza di non luogo a procedere o il proscioglimento predibattimentale.
Nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, qualora ritenga che non vi siano i presupposti per proseguire l’azione penale. In tale contesto, l’avvocato può svolgere un ruolo determinante, segnalando tempestivamente al pubblico ministero gli elementi di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione della norma. Analogamente, nelle fasi successive, il giudice può emettere sentenza di proscioglimento qualora ritenga che la condotta dell’imputato soddisfi i criteri stabiliti dall’art. 131-bis.
Un aspetto peculiare riguarda gli effetti della declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto. Sebbene l’istituto escluda l’irrogazione della pena, la sentenza che ne accerta i presupposti comporta una conferma della responsabilità penale dell’imputato. Ai sensi dell’art. 651-bis c.p.p., tale pronuncia ha efficacia di giudicato in sede civile per il risarcimento del danno, consentendo alla parte offesa di far valere le proprie pretese nei confronti dell’autore del reato. Questo aspetto rende particolarmente delicata l’applicazione della norma, poiché l’esito del procedimento penale può influire sulle dinamiche risarcitorie in ambito civile.
Un ulteriore tema rilevante è la compatibilità della tenuità del fatto con i principi del processo penale. La Corte di Cassazione ha chiarito che la causa di non punibilità non può essere invocata per la prima volta in sede di legittimità, qualora fosse già applicabile al momento della sentenza di appello. Inoltre, le Sezioni Unite hanno stabilito che i provvedimenti di archiviazione o proscioglimento per tenuità del fatto devono essere iscritti nel casellario giudiziale, ma non figurano nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro o della pubblica amministrazione.
Conclusioni: La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) e l’importanza della strategia difensiva
L’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) rappresenta un’importante evoluzione nel panorama del diritto penale italiano, ponendosi come strumento volto a ridurre il ricorso alla sanzione penale nei casi di minima offensività.
Esso consente di calibrare l’intervento repressivo in modo più proporzionato, rispettando i principi di offensività, sussidiarietà e proporzionalità, che costituiscono valori ineludibili del diritto penale moderno. L’applicazione di questo istituto, tuttavia, non è automatica, ma richiede un’analisi attenta e complessa delle circostanze del caso concreto, affidata alla valutazione discrezionale del giudice.
In questo contesto, il ruolo dell’avvocato assume una portata centrale. Attraverso un’approfondita analisi dei fatti, il difensore è in grado di individuare e valorizzare gli elementi che possono condurre all’applicazione della causa di non punibilità.
Che si tratti di far emergere la tenuità dell’offesa, l’assenza di comportamenti abituali o l’importanza della condotta susseguente al reato, l’intervento dell’avvocato è dirimente per assicurare che la norma venga applicata in modo equo e coerente.
Infine, l’istituto rappresenta anche una sfida per il sistema penale, poiché richiede un delicato bilanciamento tra le esigenze di deflazione processuale e la necessità di garantire giustizia alle vittime.
Il nostro Studio Legale, specializzato in diritto penale, si distingue per la capacità di offrire assistenza legale altamente qualificata in ogni fase del processo penale. Con un approccio dedicato e personalizzato, garantiamo una difesa solida e mirata alle esigenze specifiche del Cliente, sia esso imputato o parte civile, con l’obiettivo di far valere al massimo i suoi diritti nel rispetto delle garanzie processuali. Dedichiamo notevole attenzione all’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La preparazione e l’attenzione alle evoluzioni normative ci permettono di intervenire efficacemente in tutti i contesti legali che possono sorgere in ambito penale, dai reati comuni fino alle situazioni più complesse. Contattaci per un primo confronto, senza impegno.
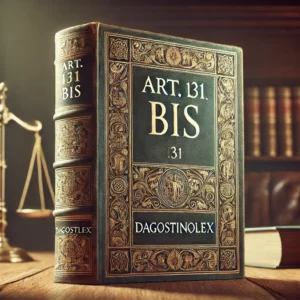
La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) nel codice penale. Studio legale specializzato in diritto penale a Roma.

da Redazione | Nov 1, 2024 | Diritto Penale
La diffamazione online è uno dei temi più attuali nel panorama del diritto penale. Se ne parla sempre più spesso a proposito della libertà di espressione e dell’uso dei mezzi di comunicazione digitale. Nell’era dei social network e della condivisione istantanea di contenuti, il rischio di ledere la reputazione altrui mediante commenti, post o articoli telematici è sempre più concreto. Spesso il ruolo dell‘avvocato penalista si rileva fondamentale.
Invero, la diffamazione online si distingue dalle forme tradizionali di diffamazione per la sua capacità di propagarsi rapidamente a un pubblico vasto, amplificando l’impatto dell’offesa e causando danni potenzialmente elevati alla dignità e alla reputazione della persona colpita.
L’obiettivo di questo articolo è fornire una sintesi delle caratteristiche del reato e della sua applicazione giurisprudenziale, avuto riguardo in particolare a casi di diffamazione online (mediante web, articoli pubblicati su testate telematiche, blog e forum, social network etc.).
Per affrontare la diffamazione online in modo efficace, analizzeremo i principali strumenti di tutela penale e, da diversa prospettiva, le modalità per ottenere un risarcimento dei danni subiti attraverso le vie civili.
Inoltre, questo articolo presenta tre regole fondamentali per una tutela penale efficace contro la diffamazione online: cautela, tempestività e acquisizione. La prima regola, la cautela, implica che la persona colpita da diffamazione mantenga sempre una condotta contenuta nelle proprie reazioni, evitando di rispondere alle provocazioni in modo impulsivo, poiché ogni replica può aggravare la situazione giuridica e compromettere le possibilità di tutela.
La seconda regola, la tempestività, evidenzia l’importanza di rivolgersi a un avvocato specializzato senza indugi, per evitare che decorrano i termini entro cui è possibile proporre querela e avviare il procedimento penale.
La terza regola, infine, riguarda l’acquisizione delle prove: la raccolta meticolosa di tutti gli elementi di prova, inclusi screenshot, link e metadati, è fondamentale per dimostrare i fatti avvenuti e supportare la propria versione dei fatti.
Affidarsi a un avvocato per un supporto legale è un passaggio di estrema importanza per chiunque subisca un danno reputazionale sul web. Solo una consulenza legale specializzata può assicurare che il percorso di tutela sia efficace e completo, sia nella fase penale che in quella civile.
Diffamazione online: definizione e caratteristiche del reato
La diffamazione online configura una particolare ipotesi di reato caratterizzata dalla diffusione di un’espressione lesiva della reputazione altrui attraverso mezzi telematici. La fattispecie è regolata dall’art. 595 del codice penale, che prevede la tutela della reputazione personale contro offese che ledano l’onore e la dignità dell’individuo, qualunque sia il mezzo utilizzato per la propalazione.
Anche per la configurazione della diffamazione online, come quella “analogica”, è necessario che l’offesa sia percepita da una pluralità di destinatari e che il soggetto passivo non sia presente al momento della diffusione. La qualificazione della diffamazione come reato d’evento richiede, inoltre, che l’espressione lesiva produca un’effettiva percezione da parte di terzi.
Nell’ambito telematico, il carattere pubblicistico delle piattaforme digitali conferisce alla diffamazione online una peculiare capacità diffusiva, amplificando la portata dell’offesa. La giurisprudenza – come si vedrà – riconosce che la divulgazione di contenuti diffamatori tramite internet realizza un’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, comma 3, c.p., in quanto commessa mediante un mezzo capace di raggiungere una pluralità di soggetti in modo simultaneo e indiscriminato.
Tale circostanza giustifica un aggravio della sanzione, data la potenziale maggiore lesività per la persona offesa. In questo senso, la diffamazione online tramite articoli telematici, social network e altre piattaforme di comunicazione digitale è stata assimilata a una pubblicazione idonea a ledere significativamente la reputazione, configurando un danno alla dignità personale in proporzione all’ampiezza del pubblico raggiunto.
Il reato di diffamazione online assume quindi una dimensione autonoma nel contesto giuridico, richiedendo un’attenta analisi delle modalità espressive e delle circostanze di pubblicazione. La giurisprudenza, negli ultimi anni, ha delineato specifici criteri per valutare la rilevanza penale di commenti, condivisioni e apprezzamenti espressi online, come i “like”, qualora questi ultimi comportino un’adesione consapevole a contenuti lesivi della reputazione altrui.
Nell’interpretazione della Corte di Cassazione, ogni condotta che concorra a diffondere o confermare il contenuto diffamatorio integra una partecipazione rilevante ai fini penali, potendo altresì aggravare la lesione della sfera morale della persona offesa.
Diffamazione online e responsabilità del direttore di periodico telematico: l’evoluzione giurisprudenziale
La questione della diffamazione online mediante testate telematiche e la possibilità di estendere la responsabilità penale del direttore responsabile ex art. 57 c.p. ha generato una copiosa evoluzione giurisprudenziale, che potremmo ripercorrere in tre momenti fondamentali.
Il primo passaggio si rinviene nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 16 luglio 2010, n. 35511, la quale – come storicamente sempre affermato dalla Suprema Corte – ha chiarito come il dettato dell’art. 57 c.p. non sia applicabile ai periodici telematici, escludendo quindi qualsiasi forma di responsabilità per omesso controllo a carico del direttore responsabile di una testata online.
La Corte ha evidenziato che «l’ambito di operatività dell’art. 57 c.p. è dunque circoscritto alla sola carta stampata» e ha sottolineato come sia vietato un ampliamento interpretativo del concetto di “stampa” per includervi le testate online.
Secondo i giudici, il principio di tassatività del diritto penale impone che l’art. 57 c.p. si applichi esclusivamente alla stampa periodica cartacea, con esclusione dei periodici digitali, poiché “la legge è inequivoca” in tal senso. Questa sentenza ha pertanto sancito il divieto di analogia in malam partem per estendere la responsabilità del direttore di un periodico telematico al reato di diffamazione online.
Il secondo passaggio evolutivo si concretizza nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 17 luglio 2015, n. 31022. In questa occasione, la Corte ha preso in esame la questione del sequestro preventivo di una pagina web contenente contenuti diffamatori, stabilendo un’importante distinzione.
Pur confermando che la responsabilità penale prevista dall’art. 57 c.p. non si estende alle testate online, la Corte ha affermato che, qualora un periodico telematico sia strutturato in modo simile alla stampa cartacea, ossia con una redazione organizzata e un direttore responsabile, esso può rientrare nella nozione di “stampa” ai soli fini del sequestro preventivo, senza che ciò comporti una responsabilità penale per il direttore.
Tale orientamento, in bonam partem, ha consentito di includere i quotidiani telematici all’interno della disciplina della stampa tradizionale, ma solo per limitare l’intervento cautelare al fine di impedire la diffusione di contenuti lesivi della reputazione altrui.
Come precisato dalla Corte, «nel concetto di “stampa” devono rientrare anche i quotidiani o i periodici on line regolarmente registrati» qualora abbiano «le caratteristiche e la struttura di un vero e proprio giornale cartaceo», ma tale assimilazione è limitata esclusivamente alla tutela della persona offesa tramite il sequestro, escludendo qualsiasi ampliamento della responsabilità penale del direttore ai sensi dell’art. 57 c.p.
Il terzo e più recente passaggio giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 23 ottobre 2018, n. 1275, che ha introdotto un cambiamento significativo nell’interpretazione della diffamazione online commessa tramite testate telematiche.
In questa pronuncia, la Corte ha stabilito che, laddove un periodico telematico sia strutturato come una testata tradizionale, con un direttore responsabile e una redazione organizzata, si configura una responsabilità per omesso controllo ai sensi dell’art. 57 c.p. In tal modo, la Corte ha esteso la portata applicativa dell’art. 57 anche ai periodici digitali, ma in malam partem, interpretando la norma nel senso che «il termine “stampa” ha anche un significato figurato» e, pertanto, include «i giornali in ogni loro forma divulgativa, che sono strumento elettivo dell’informazione».
Tale interpretazione si è basata sul concetto che l’organizzazione strutturata di una testata digitale, con un direttore e una redazione, rende il periodico telematico idoneo a raggiungere un pubblico ampio e a determinare, per tale motivo, una responsabilità penale per il direttore in caso di mancato controllo su contenuti diffamatori. In tale pronuncia, la Corte ha escluso tuttavia l’applicabilità dell’art. 57 c.p. ad altri mezzi di manifestazione del pensiero, quali blog, forum, o social network, limitando la responsabilità del direttore esclusivamente alle testate giornalistiche registrate e aventi struttura assimilabile a quella di una testata cartacea.
Questa evoluzione giurisprudenziale sulla diffamazione online mostra dunque un graduale passaggio da un’interpretazione restrittiva dell’art. 57 c.p., applicabile solo alla stampa cartacea, a una lettura che considera, con maggior ampiezza, anche le testate telematiche, sebbene con importanti limitazioni ai fini dell’applicabilità penale.
Diffamazione online e social network: responsabilità penale per commenti e condivisioni
La diffamazione online assume contorni peculiari nel contesto dei social network, dove commenti, condivisioni e apprezzamenti possono acquisire rilevanza penale qualora siano lesivi della reputazione altrui. La giurisprudenza ha affrontato in modo sistematico la problematica della responsabilità dell’utente che, interagendo su piattaforme come Facebook o Twitter, diffonda o contribuisca alla diffusione di contenuti offensivi.
La Cassazione ha stabilito che la diffamazione online realizzata tramite social network può configurare un’ipotesi di reato aggravato ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., poiché tale mezzo di comunicazione, in ragione della sua ampia capacità diffusiva, è idoneo a raggiungere una pluralità di destinatari in tempi brevi e con effetti amplificati.
Per quanto riguarda le condivisioni, la giurisprudenza prevalente ritiene che la mera condivisione di un messaggio diffamatorio non integri necessariamente gli estremi della diffamazione online ai sensi dell’art. 595 c.p., sebbene vi siano circostanze in cui tale atto può essere considerato penalmente rilevante.
Secondo la Cassazione, «la condotta materiale [dell’utente che condivide] non evidenzia oggettivamente alcuna adesione ai contenuti offensivi, laddove non emergano elementi che indichino un’intenzione di rafforzare l’offesa alla persona». La valutazione della responsabilità per condivisione richiede, quindi, un’analisi delle modalità concrete in cui tale condotta è stata posta in essere, considerando se l’utente abbia manifestato una volontà di sostenere o intensificare l’offesa.
In relazione alla manifestazione di gradimento tramite “like” o altre reazioni, la giurisprudenza ha riconosciuto che tali interazioni sono spesso ambigue e non sempre esprimono un’adesione alla portata diffamatoria del messaggio.
Tuttavia, qualora un utente apponga un “like” su un post offensivo, senza ulteriori espressioni di dissenso, potrebbe desumersi una volontà di supporto implicito al contenuto diffamatorio, configurando quindi una partecipazione indiretta alla diffamazione online. È stato inoltre evidenziato che il ruolo degli algoritmi di visibilità di alcune piattaforme social, come Instagram, che aumentano la diffusione dei post apprezzati da un numero elevato di utenti, può potenzialmente contribuire all’effetto lesivo dell’offesa.
Nonostante ciò, la giurisprudenza ritiene che la mera reazione di gradimento, di per sé, non sia sufficiente a integrare la condotta tipica di cui all’art. 595 c.p., costituendo, al limite, un’ipotesi di reato impossibile ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p., laddove non sia provato l’intento di esaltare o promuovere il contenuto diffamatorio.
In definitiva, la responsabilità per diffamazione online sui social network si configura prevalentemente nei casi in cui il commento o la condivisione risulti palesemente offensiva e diretta a una pluralità di destinatari, rafforzando l’offesa arrecata. Il contesto e le modalità della comunicazione, nonché la consapevolezza dell’utente in merito alla portata lesiva del contenuto, restano criteri determinanti per configurare o escludere la responsabilità penale in queste fattispecie.

Protezione legale contro la diffamazione sui social network. Lo studio legale D’Agostino a Roma offre consulenza su reati online, querela e risarcimento per offese telematiche.
Diffamazione online e diffamazione non nominativa: quando l’identificazione è implicita
La diffamazione online può configurarsi anche in assenza di un riferimento nominativo esplicito alla persona offesa, purché l’identificazione del soggetto leso risulti possibile per una cerchia di destinatari del messaggio. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da un gruppo di persone, anche senza un’esplicita menzione del nome.
La Cassazione ha statuito che «per la configurazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto leso sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa» (Cass. Pen., Sez. I, 16 aprile 2014, n. 16712).
Un esempio significativo si rinviene nel caso esaminato dalla Corte Militare d’Appello di Roma, in cui l’imputato era stato assolto in appello con la motivazione che l’identificazione della persona offesa risultava possibile solo per una ristretta cerchia di soggetti sul social network e in assenza di riferimenti nominativi. Tuttavia, la Cassazione ha annullato tale pronuncia, rilevando che anche una cerchia ristretta di individui, legati in modo più o meno stretto alla persona offesa, può percepire la lesività del contenuto diffamatorio, rendendo irrilevante l’assenza di un riferimento diretto.
La Corte ha stabilito che, qualora gli elementi descrittivi contenuti nel messaggio permettano a una specifica cerchia di soggetti di identificare il destinatario dell’offesa, la diffamazione online è configurata anche se l’autore del messaggio utilizza espressioni volutamente generiche o allusive.
Secondo la giurisprudenza, la valutazione della diffamazione online non nominativa richiede un’analisi del contesto sociale e delle relazioni tra i soggetti coinvolti, tenendo conto di fattori quali la familiarità del pubblico di riferimento con la vittima e la possibilità che la descrizione generica conduca all’identificazione del soggetto offeso. È quindi necessario che l’espressione offensiva assuma un significato univoco per i destinatari, anche in assenza di una menzione esplicita, e che il contenuto sia percepito come riferito al soggetto leso all’interno della specifica comunità online.
L’identificabilità implicita costituisce, quindi, un criterio di fondamentale rilevanza nel determinare la sussistenza della diffamazione online non nominativa. La giurisprudenza richiede, a tal fine, che il giudice verifichi la riferibilità soggettiva delle espressioni utilizzate, prendendo in considerazione il contesto digitale e l’accesso selettivo al contenuto da parte di una cerchia specifica di soggetti, affinché sia garantita la tutela della reputazione anche in caso di offese indirette.
Diffamazione online e il locus commissi delicti: questioni relative alla competenza territoriale
La determinazione del locus commissi delicti nella diffamazione online rappresenta una questione di particolare complessità, data la natura ubiquitaria e pervasiva delle comunicazioni digitali. La giurisprudenza ha dovuto affrontare la difficoltà di individuare il luogo in cui si consuma il reato, poiché, nell’ambito telematico, la diffusione del messaggio offensivo può avvenire a livello globale e la sua percezione non è vincolata a una specifica area geografica. In questo contesto, la Corte di Cassazione ha delineato un principio fondamentale: la diffamazione online è un reato di evento, la cui consumazione è legata alla percezione del messaggio lesivo da parte di terzi.
La sentenza della Cassazione, Sez. V Penale, 17 novembre 2000, n. 4741, ha chiarito che la consumazione del reato di diffamazione non si verifica al momento della pubblicazione del contenuto diffamatorio, bensì quando il messaggio offensivo viene percepito dai destinatari, i quali costituiscono il “pubblico” che consente la concretizzazione dell’offesa.
In tale sentenza, la Corte ha stabilito che, per quanto riguarda i reati commessi tramite internet, il momento consumativo della diffamazione online coincide con il momento in cui il messaggio è percepito da soggetti «terzi» rispetto all’autore e alla persona offesa.
Questo orientamento comporta che, una volta che il contenuto diffamatorio sia stato visualizzato anche sul territorio italiano, la giurisdizione e la competenza territoriale si radicano presso il giudice italiano, indipendentemente dal luogo in cui il messaggio è stato originariamente generato e pubblicato.
Per stabilire la competenza territoriale all’interno dell’Italia, si è affermata la prassi di considerare il luogo di residenza, domicilio o dimora della persona offesa come riferimento territoriale, partendo dal presupposto che il soggetto leso abbia potuto accedere al contenuto lesivo nel luogo in cui abitualmente dimora. Questo principio consente al giudice competente di fondare la propria giurisdizione sulla base dell’effettiva percezione del danno morale subito dalla vittima, conferendo così un criterio chiaro per la proposizione della querela e per l’eventuale azione risarcitoria.
La diffamazione online presenta, dunque, una configurazione territoriale peculiare, dove il luogo di consumazione del reato viene individuato non in relazione alla fonte della pubblicazione, bensì al luogo di percezione del contenuto diffamatorio da parte della persona offesa. Tale approccio permette di tutelare adeguatamente la dignità e la reputazione dell’individuo, in un contesto in cui la comunicazione digitale trascende le barriere geografiche e richiede, pertanto, una regolamentazione adeguata a una rete globalmente accessibile.
Diffamazione online: aggravante del mezzo di pubblicità e tutela risarcitoria in sede civile
La diffamazione online è comunemente trattata come una fattispecie aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., in quanto realizzata mediante un mezzo di pubblicità idoneo a determinare una maggiore diffusività dell’offesa.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nel contesto digitale, il reato di diffamazione si configura in forma aggravata poiché il mezzo telematico consente di raggiungere un numero potenzialmente indeterminato di persone, aumentando l’intensità del danno alla persona offesa. La Cassazione ha chiarito che l’aggravante si giustifica per la natura del mezzo utilizzato, il quale, «per potenzialità e idoneità, è capace di coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone […] cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa» (Cass. Pen., Sez. I, 28 aprile 2015, n. 24431).
La diffusione dell’offesa tramite piattaforme digitali e social network comporta quindi un aggravio della responsabilità dell’autore, poiché la comunicazione virtuale amplifica l’impatto della lesione reputazionale.
A fronte di tale potenziale gravità, la persona offesa dalla diffamazione online dispone di strumenti di tutela non solo in ambito penale, ma anche sul piano civile, tramite un’azione risarcitoria finalizzata alla riparazione dei danni morali e materiali subiti.
L’azione civile per risarcimento danni è accessibile sia mediante costituzione di parte civile nel processo penale, sia tramite avvio di un autonomo procedimento civile. La giurisprudenza civile ha stabilito che il danno risarcibile può comprendere sia il pregiudizio alla sfera morale, per la sofferenza e il discredito subito dalla vittima, sia il danno patrimoniale, qualora la diffamazione online abbia compromesso la posizione sociale o professionale del soggetto leso. In particolare, l’accertamento della sussistenza e della quantificazione del danno subito presuppone una valutazione complessiva del contesto in cui si è verificata la diffamazione, della notorietà della persona offesa e dell’ampiezza della diffusione dell’offesa.
In ambito civile, la persona danneggiata dalla diffamazione online può inoltre agire per ottenere la rimozione dei contenuti lesivi e la pubblicazione della sentenza di condanna, al fine di ripristinare la propria reputazione.
La combinazione degli strumenti penali e civili risulta particolarmente efficace in caso di diffamazione telematica, consentendo alla vittima di perseguire un’adeguata riparazione per l’offesa subita e di proteggere la propria immagine nell’ambiente sociale e professionale di appartenenza. Tali rimedi giuridici, posti in essere con l’assistenza di un legale specializzato, assicurano una tutela integrata della persona offesa, che può così affrontare gli effetti della diffamazione online su più fronti, ottenendo giustizia sia in termini di sanzione all’autore del reato, sia in termini di risarcimento e ripristino dell’onore leso.
Conclusioni: tre regole per una tutela penale efficace contro la diffamazione online
La diffamazione online, per la sua pervasività e capacità di causare danni reputazionali estesi, richiede strumenti di tutela che agiscano su più livelli, sia sul piano penale che civile. La giurisprudenza italiana ha delineato un quadro di interventi che permettono alla persona offesa di reagire in modo efficace, grazie alla possibilità di perseguire non solo l’autore dell’offesa, ma anche eventuali responsabili editoriali nel caso delle testate telematiche registrate.
Per affrontare efficacemente una diffamazione online, è utile seguire tre regole fondamentali che garantiscono una maggiore tutela e protezione dei propri diritti:
- Cautela: è fondamentale evitare di rispondere alle provocazioni in modo impulsivo o aggressivo. Mantenere una continenza espositiva è essenziale per non aggravare la situazione e per conservare una condotta coerente con i requisiti richiesti per avviare una querela per diffamazione. La cautela impedisce che eventuali reazioni inopportune possano essere utilizzate contro la vittima stessa, compromettendo la possibilità di ottenere giustizia.
- Tempestività: è determinante per la difesa dei propri diritti. È necessario rivolgersi prontamente a un avvocato specializzato in diritto penale, per assicurarsi che i termini per la proposizione della querela non vengano superati. Ai sensi dell’art. 120 c.p., il termine per presentare querela è di tre mesi dalla conoscenza del fatto lesivo, decorso il quale il reato non sarà più perseguibile. Agire tempestivamente garantisce l’accesso alla tutela penale e consente all’avvocato di predisporre una strategia di difesa adeguata.
- Acquisizione delle prove: raccogliere e conservare tutte le prove disponibili è un passaggio cruciale per l’azione legale. Screenshot, link, metadati e altre evidenze digitali devono essere raccolti per documentare la lesione subita e facilitare il lavoro di difesa da parte del legale. L’acquisizione meticolosa degli elementi di prova permette di rafforzare la propria posizione e di ottenere un riscontro più solido nei confronti dell’autore dell’offesa.
Seguendo queste tre regole, è possibile intraprendere un percorso di tutela contro la diffamazione online con maggiori probabilità di successo. Affidarsi allo Studio Legale D’Agostino consente di orientarsi nelle complessità del diritto e ottenere una tutela effettiva delle proprie ragioni.

Tutela legale per reati di diffamazione sui social network. Lo studio legale D’Agostino a Roma offre consulenza per querela, offesa telematica e risarcimento danni.

da Redazione | Ott 24, 2024 | Diritto Penale
L’avvocato penalista svolge un ruolo fondamentale nell’ordinamento giuridico, poiché rappresenta e difende coloro che sono accusati di un reato (esempio, per citare i più comuni, furto, rapina, lesioni personali, truffa o omicidio).
Il suo compito primario è garantire una difesa adeguata all’imputato, tutelando i suoi diritti durante tutto il processo penale, in diversi ambiti. Questa figura si distingue per la sua capacità di analizzare gli atti processuali, elaborare strategie difensive e rappresentare il cliente sia nelle fasi preliminari che in quelle dibattimentali, fino all’eventuale ricorso in appello o in cassazione.
Oltre al ruolo dell’avvocato penalista nella difesa dell’imputato, va considerata anche la figura del difensore della parte civile, nel caso in cui la persona offesa dal reato decida di costituirsi parte civile nel processo. In questa veste, l’avvocato rappresenta gli interessi della vittima, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di reati quali lesioni personali, truffa, ricettazione o estorsione.
In aggiunta, finché la persona offesa non si costituisce parte civile, il suo avvocato agisce per tutelare i diritti del proprio assistito in quanto persona offesa, collaborando con le autorità inquirenti durante il procedimento. Anche in questo caso, l’avvocato penalista riveste un ruolo cruciale nel garantire che la persona offesa ottenga giustizia.
Nel corso della storia, il ruolo dell’avvocato penalista si è evoluto di pari passo con i modelli processuali. Nell’antica Roma, la difesa era affidata al patronus, una figura dotata di grande prestigio sociale, che assisteva l’accusato in un sistema più vicino al modello inquisitorio, in cui il giudice aveva un ruolo attivo nella ricerca della verità.
Con il passaggio al modello accusatorio, che caratterizza i moderni sistemi processuali, l’avvocato penalista ha acquisito una funzione centrale: la difesa è infatti posta su un piano di parità rispetto all’accusa, e il processo si basa sul contraddittorio tra le parti. Questo cambiamento ha rafforzato la posizione dell’avvocato, che oggi assume un ruolo decisivo nell’esito del procedimento.
L’obiettivo di questo articolo è fornire una panoramica esaustiva del ruolo dell’avvocato penalista nel contesto giuridico odierno, delineando i suoi compiti e responsabilità, così come la sua importanza nella difesa dei diritti fondamentali dell’imputato.
Cercheremo di chiarire i connotati essenziali di questa professione, che continua a evolversi insieme al sistema legale. In un processo penale, la presenza di un avvocato penalista competente è imprescindibile per garantire che l’imputato riceva un trattamento equo e che i principi di giustizia vengano rispettati.
L’avvocato penalista a Roma: il patronus e l’evoluzione della difesa nel processo penale
Nell’antica Roma, la figura dell’avvocato penalista era incarnata principalmente dal patronus, un personaggio di spicco che rappresentava e difendeva gli interessi dell’accusato in tribunale. Il ruolo del patronus nell’antica Roma era strettamente legato all’eloquenza e all’oratoria, poiché la capacità di convincere i giudici attraverso argomentazioni ben strutturate era essenziale per la difesa.
A differenza dell’avvocato penalista moderno, il patronus non era necessariamente un professionista del diritto, ma spesso un politico o un membro della classe aristocratica, che godeva di un certo prestigio sociale e che offriva la sua protezione ai clienti.
La giurisprudenza romana, in particolare durante l’epoca repubblicana, non aveva ancora istituzionalizzato la figura dell’avvocato come la conosciamo oggi. Tuttavia, il patronus svolgeva un ruolo fondamentale nella difesa di individui accusati di reati come omicidio, furto o lesioni personali. Tra i più celebri avvocati penalisti dell’antica Roma vi è Marco Tullio Cicerone, famoso per le sue arringhe difensive in cause di grande rilievo penale, come il processo a Sesto Roscio per parricidio.
In questo contesto, la difesa penale a Roma era profondamente legata ai rapporti personali e di clientela tra il patronus e i suoi assistiti, i clientes. Nonostante la mancanza di una regolamentazione formale, il patronus assumeva una funzione centrale nel garantire una difesa effettiva, svolgendo un ruolo che può essere visto come un precursore dell’attuale avvocato penalista.
Con l’evoluzione del sistema giuridico romano, si delinearono le basi di ciò che oggi è la professione dell’avvocato penalista. L’importanza della difesa in un sistema penale complesso come quello romano ha lasciato un’impronta significativa sulla successiva elaborazione del diritto, influenzando profondamente i modelli giuridici odierni e consolidando Roma come culla del diritto.
L’avvocato penalista dall’Ottocento alla Costituzione Italiana: l’evoluzione del diritto alla difesa
L’affermazione del ruolo dell’avvocato penalista ha subito un’importante evoluzione nel corso dell’Ottocento, con il consolidamento degli Stati moderni e la nascita dei primi codici penali e processuali. In Italia, il ruolo dell’avvocato penalista cominciò a definire contorni sempre più precisi con l’introduzione del Codice penale del Regno di Sardegna (1839) e successivamente con il Codice Zanardelli del 1889.
Questi testi normativi, per la prima volta, sancirono la presenza di una difesa tecnica obbligatoria in tutti i procedimenti penali, valorizzando la figura dell’avvocato penalista come essenziale per il giusto processo.
Tuttavia, è con la nascita della Costituzione Italiana del 1948 che il ruolo dell’avvocato penalista trova il suo riconoscimento formale e costituzionale, a partire dall’art. 24. Questo articolo stabilisce il diritto inviolabile di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e sottolinea che “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. L’avvocato penalista diventa così una figura centrale per garantire che ogni cittadino possa difendersi adeguatamente, in linea con i principi dello Stato di diritto.
In aggiunta, l’art. 111 della Costituzione Italiana introduce il principio del giusto processo, secondo il quale il procedimento deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. Questo principio costituzionale pone l’avvocato penalista sullo stesso piano del pubblico ministero, garantendo così all’imputato una difesa effettiva. La Costituzione assicura inoltre che ogni processo si svolga con l’assistenza di un difensore, esplicitando l’importanza del ruolo dell’avvocato penalista nell’ordinamento giuridico italiano.
Nel corso del tempo, l’avvocato penalista ha assunto una funzione sempre più rilevante non solo nella difesa degli imputati, ma anche nella protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, soprattutto in casi complessi come quelli relativi a reati gravi. In questo modo, il professionista del diritto penale contribuisce a realizzare una giustizia equilibrata e a garantire il rispetto dei principi costituzionali.
La disciplina dell’avvocato penalista nel vigente codice di procedura penale
Nel Codice di Procedura Penale attualmente in vigore, la figura dell’avvocato penalista è regolata da una serie di norme che ne stabiliscono ruoli, diritti e doveri, assicurando che la difesa degli imputati e delle altre parti processuali sia sempre garantita.
Il legislatore ha riconosciuto all’avvocato penalista una posizione centrale nel sistema penale italiano, ribadendo il principio secondo cui la difesa è un diritto inviolabile, come sancito dall’art. 24 della Costituzione Italiana. Questo diritto viene tradotto in norme precise che disciplinano l’attività del difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio.
L’art. 96 del Codice di Procedura Penale afferma che “l’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia”. La nomina del difensore di fiducia è una scelta libera e personale da parte dell’imputato, che può così selezionare un avvocato penalista di sua fiducia per rappresentarlo durante tutte le fasi del processo penale.
La nomina del difensore deve essere comunicata all’autorità procedente o trasmessa dal difensore stesso, e può essere fatta anche da un prossimo congiunto nel caso di imputati fermati o arrestati. Questa disposizione rafforza il rapporto fiduciario tra l’imputato e il suo difensore, un legame cruciale per una difesa efficace, soprattutto in processi complessi che possono riguardare reati come omicidio, rapina o riciclaggio.
L’art. 97 regola la figura del difensore d’ufficio, il quale interviene nei casi in cui l’imputato non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. La norma prevede che il difensore d’ufficio venga scelto da un elenco nazionale di avvocati penalisti che svolgono tale compito.
L’elenco tiene conto di criteri come la prossimità territoriale e la reperibilità. Questo garantisce che l’imputato, anche se non ha scelto o non può scegliere un difensore, non sia mai privo di assistenza legale qualificata.
Inoltre, il difensore d’ufficio è tenuto a prestare il patrocinio senza possibilità di rifiutare l’incarico, salvo giustificato motivo. La sua funzione termina automaticamente nel momento in cui l’imputato nomina un difensore di fiducia. È importante sottolineare che il difensore d’ufficio gode degli stessi diritti e facoltà di un difensore di fiducia, il che garantisce una parità di trattamento e tutela per l’imputato, indipendentemente dalla sua capacità di scegliere un difensore privato.
Per assicurare che anche le persone in difficoltà economica possano godere di una difesa adeguata, l’art. 98 disciplina il patrocinio a spese dello Stato. Questo diritto può essere richiesto dall’imputato, dalla persona offesa dal reato o dal danneggiato che intende costituirsi parte civile, nonché dal responsabile civile.
Il patrocinio a spese dello Stato garantisce che, in presenza di determinati requisiti reddituali, le spese legali siano coperte dallo Stato, consentendo così a tutti i cittadini di accedere a una difesa qualificata, anche nei casi di reati complessi come estorsione, rissa o lesioni personali.
Diritti e facoltà dell’avvocato penalista. La disciplina del codice.
L’art. 99 estende al difensore “le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato”, a meno che questi siano espressamente riservati all’imputato stesso. Questo significa che l’avvocato penalista può compiere, nell’interesse dell’imputato, una serie di atti che vanno dalla presentazione di memorie difensive alla partecipazione agli atti istruttori. Tuttavia, l’imputato ha la facoltà di togliere efficacia agli atti compiuti dal difensore, purché lo faccia con una dichiarazione espressa prima che il giudice abbia emesso un provvedimento sull’atto in questione.
Questa norma rafforza il ruolo attivo del difensore nel processo penale, conferendogli ampie possibilità di intervenire a tutela dei diritti dell’imputato. L’avvocato penalista, infatti, può esercitare il diritto di impugnare le decisioni sfavorevoli, proporre eccezioni procedurali e, in generale, partecipare in modo attivo al contraddittorio tra le parti, garantendo così l’equità del processo.
Oltre alla difesa dell’imputato, l’art. 100 disciplina la figura del difensore delle altre parti private nel processo penale, come la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Queste parti possono costituirsi in giudizio solo attraverso un difensore, munito di procura speciale.
Anche in questo caso, l’avvocato penalista svolge un ruolo cruciale nel rappresentare e difendere gli interessi delle parti, soprattutto nelle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti da reati.
Un aspetto di particolare rilievo per la tutela dei diritti dell’imputato è disciplinato dall’art. 104, che garantisce all’imputato in custodia cautelare il diritto di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura.
Questo diritto si estende anche agli arrestati in flagranza o ai fermati, che possono conferire con il proprio avvocato penalista subito dopo l’arresto o il fermo. Questo contatto immediato tra imputato e difensore è cruciale per preparare una strategia difensiva efficace sin dalle prime fasi del procedimento penale.
Infine, l’art. 106 affronta la questione dell’incompatibilità nella difesa di più imputati nello stesso procedimento penale. La difesa comune è consentita solo se le posizioni degli imputati non sono tra loro incompatibili. Se l’autorità giudiziaria rileva una situazione di incompatibilità, provvede a rimuoverla con l’assegnazione di un nuovo difensore. In questo modo, si garantisce che ogni imputato sia assistito in modo equo e imparziale da un avvocato penalista, evitando conflitti di interesse.
In sintesi, il Codice di Procedura Penale delinea un sistema complesso e articolato in cui l’avvocato penalista svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dell’imputato e delle altre parti processuali. Le norme che regolano l’attività del difensore assicurano che la difesa sia sempre garantita, indipendentemente dalla situazione economica o dalle capacità personali dell’imputato, in piena conformità ai principi costituzionali del giusto processo e del diritto alla difesa.
L’importanza dell’avvocato penalista nell’accertamento della responsabilità penale
Nel processo penale, la difesa tecnica attraverso il patrocinio di un avvocato penalista è un elemento imprescindibile per garantire i diritti dell’imputato e delle altre parti coinvolte, salvo rare eccezioni previste dalla legge.
Molti istituti processuali, infatti, sono stati strutturati considerando la partecipazione attiva del difensore, la cui presenza è necessaria per tutelare la parte assistita, sia essa l’imputato o la parte civile. Per quanto riguarda l’imputato, il codice di procedura penale prevede – come detto pocanzi – che egli “ha il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia” (art. 96 c.p.p.), e, in mancanza di tale nomina, sarà assistito da un difensore d’ufficio (art. 97 c.p.p.). Questo sistema garantisce che ogni persona accusata di reati come abbia una rappresentanza legale qualificata.
Il procedimento penale, che si snoda attraverso diverse fasi – dalle indagini preliminari all’udienza dibattimentale, fino all’eventuale pronuncia della Corte d’Assise – richiede l’intervento costante di un avvocato penalista.
In ogni fase, l’attività del difensore risulta determinante per assicurare il rispetto delle garanzie processuali previste dalla legge, a tutela sia dell’imputato sia delle altre parti coinvolte. Questo è vero non solo per le fasi più avanzate del processo, ma anche nel momento in cui viene presentata una denuncia o una querela, o quando si compiono i primi atti d’indagine, come l’audizione dell’indagato.
Affidare un caso allo Studio legale Avv. Luca D’Agostino, specializzato in diritto penale, significa poter contare su una difesa tecnica e un’assistenza specialistica per garantire la tutela dei propri diritti, sempre con la massima riservatezza e professionalità.
Il ruolo di un avvocato penalista nelle misure cautelari e di prevenzione
Le misure cautelari, previste dall’art. 274 del Codice di Procedura Penale, sono provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria per prevenire il rischio di fuga dell’imputato, la reiterazione del reato o l’inquinamento probatorio. Sebbene queste misure siano applicate prima dell’accertamento definitivo dei fatti, possono comportare pesanti limitazioni della libertà personale e patrimoniale dell’imputato. Tra le misure più comuni vi sono la custodia in carcere, gli arresti domiciliari e il sequestro preventivo di beni mobili e immobili (art. 321 c.p.p.).
Nonostante il principio di innocenza sancito dall’art. 27, comma 2, della Costituzione Italiana, che stabilisce che l’imputato non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva, è frequente che durante la fase delle indagini il pubblico ministero richieda e ottenga l’applicazione di una misura cautelare. In queste circostanze, l’intervento dell’avvocato penalista è cruciale per garantire che la limitazione dei diritti fondamentali avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge.
Il difensore deve infatti vigilare affinché vi siano i “gravi indizi di colpevolezza” e che le “esigenze cautelari” siano effettivamente sussistenti, elementi necessari per l’applicazione di queste misure restrittive.
Inoltre, l’avvocato penalista può proporre istanze di riesame o appello cautelare per contestare la decisione del giudice o del pubblico ministero, cercando di ottenere la revoca o la modifica della misura applicata. Le tempistiche per presentare tali istanze sono spesso ristrette, e il procedimento cautelare è caratterizzato da regole peculiari rispetto al rito ordinario, richiedendo una preparazione specifica e un’attenzione particolare ai dettagli.
Affidare la propria difesa allo Studio legale Avv. Luca D’Agostino, specializzato in diritto penale, permette di affrontare situazioni complesse come l’applicazione delle misure cautelari con la massima competenza, assicurando un’assistenza legale tempestiva e qualificata.

Misure cautelari e di prevenzione – Studio Legale Avvocato D’Agostino, Roma.
Il ruolo di un avvocato penalista nell’esecuzione penale
Il processo penale non si esaurisce con la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna o proscioglimento. Anche successivamente, infatti, possono sorgere questioni rilevanti legate all’esecuzione della pena o all’applicazione di istituti di diritto processuale penale. In questa fase, l’avvocato penalista continua a svolgere un ruolo fondamentale, garantendo che l’esecuzione penale sia conforme ai principi di giustizia sostanziale e rieducatività della pena, come previsto dall’art. 27 della Costituzione Italiana.
L’esecuzione penale è normalmente affidata al pubblico ministero, che ha il potere di emettere ordini di carcerazione e altri provvedimenti esecutivi. Tuttavia, vi sono questioni che devono essere sottoposte al giudice dell’esecuzione, il quale è chiamato a decidere su problematiche come la legittimità del titolo esecutivo, l’applicazione di amnistia o indulto, la revoca di benefici concessi durante il processo, o l’estinzione del reato.
Inoltre, la magistratura di sorveglianza ha competenza in materia di misure alternative alla detenzione, esecuzione di sanzioni sostitutive e applicazione di misure di sicurezza.
In ciascuna di queste situazioni, l’attività dell’avvocato penalista è essenziale. Attraverso la presentazione di istanze, richieste e appelli, il difensore si impegna a garantire che l’esecuzione della pena avvenga nel rispetto dei diritti dell’imputato, assicurando che la sanzione sia proporzionata, legittima e, quando possibile, orientata al recupero sociale del condannato. Le decisioni prese in questa fase incidono in maniera determinante su aspetti cruciali della vita del condannato, come la libertà personale e la reputazione.
Affidarsi allo Studio legale Avv. Luca D’Agostino, specializzato in diritto penale, significa poter contare su un’assistenza legale qualificata e su professionisti esperti, che affrontano con competenza le delicate questioni relative all’esecuzione penale, avvalendosi anche del supporto di professionisti in ambito medico, psicologico e criminologico.

Esecuzione penale, avvocato penalista condanna e appello – Studio Legale Avvocato D’Agostino, Roma.
Da Roma a giorni nostri: l’avvocato penalista per una difesa efficace
Scegliere un avvocato penalista è una decisione cruciale per chi si trova a dover affrontare un procedimento penale, indipendentemente dalla gravità del reato contestato. Che si tratti di difendere un imputato dall’accusa di reati gravi come omicidio, estorsione, riciclaggio o reati più comuni come truffa, furto e lesioni personali, l’intervento di un avvocato penalista esperto garantisce il rispetto dei diritti fondamentali della persona coinvolta. La difesa tecnica, infatti, non solo è un diritto sancito dalla Costituzione Italiana, ma è anche indispensabile per assicurare un processo equo e conforme ai principi di giustizia.
La figura dell’avvocato penalista svolge un ruolo decisivo durante tutte le fasi del procedimento penale: dalle indagini preliminari, fino alla fase dibattimentale e all’esecuzione della pena, garantendo che ogni atto del procedimento sia compiuto nel rispetto della legge.
Il difensore penale assiste il cliente anche nelle delicate questioni legate alle misure cautelari, come la custodia cautelare o il sequestro preventivo, che limitano la libertà personale e patrimoniale. È in questa fase che l’abilità e l’esperienza di un avvocato penalista diventano essenziali per assicurare una difesa solida e strategica.
Affidarsi a uno studio legale specializzato in diritto penale permette di affrontare il processo con la consapevolezza di avere al proprio fianco un professionista in grado di gestire le complessità della procedura penale, anche in casi particolarmente delicati o complessi. Lo Studio legale Avv. Luca D’Agostino, con la sua esperienza in ambito penale, è in grado di offrire una difesa qualificata in ogni fase del procedimento.

Difesa nel processo penale – Studio Legale Luca D’Agostino, Roma.
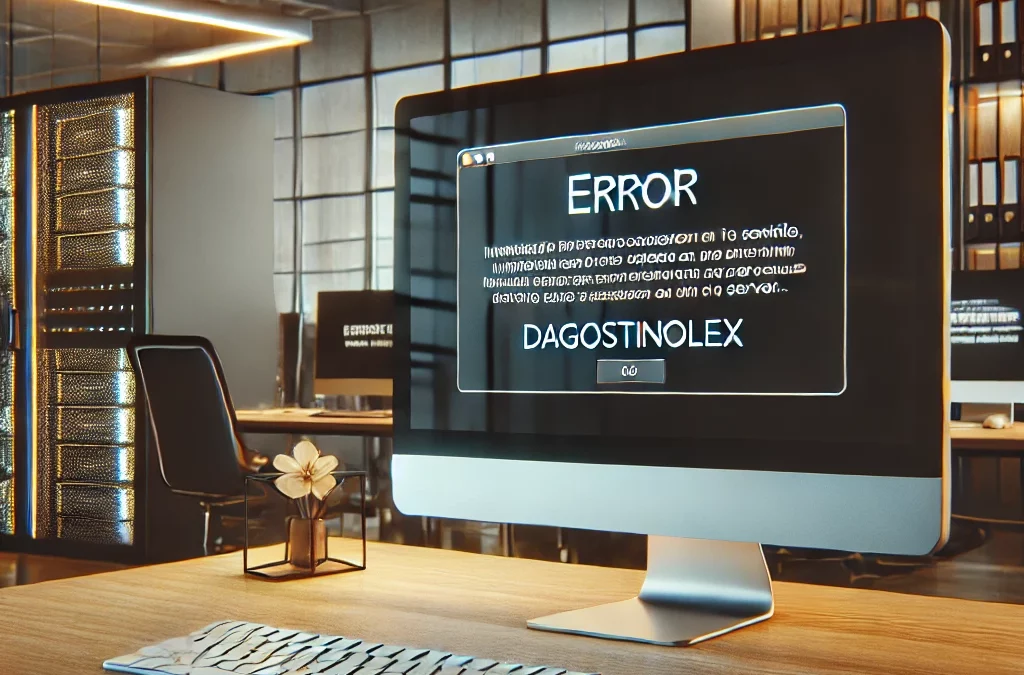
da Redazione | Ott 24, 2024 | Diritto Penale, Diritto d'Impresa
Il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-ter del codice penale, costituisce una delle fattispecie centrali nel sistema repressivo della criminalità informatica. Tale reato punisce chi, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Introdotto nel 1993, il reato si è imposto come uno degli strumenti giuridici più efficaci per contrastare le intrusioni non autorizzate nel cyberspazio, anche grazie alla sua ampia applicabilità e alla rilevanza assunta nel contesto della protezione dei dati e delle informazioni digitali.
L’accesso abusivo si configura come una condotta prodromica, poiché spesso rappresenta il primo atto di una serie di comportamenti illeciti che possono verificarsi all’interno di un sistema informatico, come il furto di dati, la distruzione di informazioni o il danneggiamento del sistema stesso.
Con l’applicazione della norma nel corso degli anni, la giurisprudenza ha riconosciuto che l’accesso abusivo può configurarsi anche quando un soggetto legittimamente autorizzato a utilizzare il sistema superi i limiti della propria autorizzazione, mantenendosi all’interno del sistema in modo illecito. Questo fenomeno, noto come insider abuse, amplia notevolmente il campo di applicazione dell’art. 615-ter c.p., rendendolo rilevante non solo per le intrusioni esterne, ma anche per quelle compiute da soggetti interni che sfruttano il loro ruolo per fini illeciti.
L’obiettivo di questo articolo è fornire una panoramica chiara sul reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, delineando le principali caratteristiche della fattispecie e l’evoluzione giurisprudenziale che l’ha riguardata.
Trattandosi di un reato che tocca aspetti complessi e in continua evoluzione, è fondamentale per imprese e individui, beneficiare di un’assistenza legale specialistica per prevenire rischi legali e assicurare la corretta gestione di eventuali responsabilità derivanti dall’accesso abusivo a sistemi informatici.
Struttura del reato di accesso abusivo
Il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, disciplinato dall’art. 615-ter del codice penale, si articola in due condotte alternative: l’introduzione abusiva e la permanenza non autorizzata all’interno del sistema.
La prima condotta si verifica quando un soggetto, senza avere il permesso del titolare del sistema, supera le misure di sicurezza predisposte e si introduce all’interno del sistema informatico o telematico. Tale introduzione può avvenire sia da remoto, utilizzando un dispositivo diverso dall’elaboratore, sia attraverso un contatto diretto con il sistema.
Ciò che rileva ai fini della configurazione del reato è l’avvio di un dialogo logico con il software, che consente all’agente di operare all’interno del sistema. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che il soggetto attivo prenda effettiva cognizione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema; ciò che conta è che egli abbia violato le barriere di protezione che ne regolano l’accesso.
La seconda condotta, quella di permanenza abusiva, si configura quando un soggetto, che ha avuto legittimo accesso al sistema, vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita, del titolare. In questo caso, la condotta diviene illecita non per l’accesso iniziale, che può essere stato lecito, ma per il mantenimento della connessione al sistema oltre i limiti imposti dal titolare.
Tale permanenza non si deve intendere in senso fisico, bensì come il mantenimento di una connessione logica con il sistema, che inizialmente poteva essere autorizzata ma successivamente diviene contraria alla volontà del titolare. Anche in questo caso, la condotta illecita può realizzarsi sia con un accesso diretto al sistema sia da remoto.
Il requisito essenziale che accomuna entrambe le condotte è l’elemento dell’abusività, che implica un conflitto tra il soggetto attivo e il titolare del sistema. L’abusività è evidente quando l’agente non possiede alcuna autorizzazione per accedere al sistema, ma può anche configurarsi nel caso in cui l’accesso sia avvenuto legittimamente e poi il soggetto ecceda i limiti dell’autorizzazione. In entrambi i casi, l’art. 615-ter c.p. richiede che vi sia una violazione della volontà del titolare di escludere l’agente dall’accesso al sistema o dal permanere all’interno dello stesso.
L’oggetto materiale del reato è rappresentato dal sistema informatico o telematico, inteso come un insieme di apparecchi e programmi che consentono l’elaborazione e la gestione di informazioni. Sebbene il codice penale non fornisca una definizione specifica di sistema informatico o telematico, la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che rientrano in questa categoria tutti i sistemi elettronici che permettono la memorizzazione, il trattamento e lo scambio di dati attraverso reti di comunicazione.
Le modalità tecniche con cui l’accesso o la permanenza abusiva si realizzano possono essere diverse, ma ciò che conta è l’effettiva instaurazione di una connessione logica con il sistema, indipendentemente dall’effettiva cognizione dei dati o dei programmi in esso contenuti.
Infine, l’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, ossia dalla consapevolezza e volontà del soggetto di introdursi o di permanere abusivamente all’interno del sistema, sapendo di non essere autorizzato.
Il reato si consuma nel momento in cui si instaura la connessione con il sistema, ossia quando l’agente supera le misure di protezione predisposte dal titolare e acquisisce il controllo del sistema, anche senza utilizzare i dati in esso contenuti. Nel caso della permanenza illecita, il momento consumativo coincide con il mantenimento della connessione contro la volontà del titolare.
Le circostanze aggravanti dell’accesso abusivo
Il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-ter c.p., prevede una serie di circostanze aggravanti che incidono sul trattamento sanzionatorio.
Tali circostanze sono state oggetto di numerose modifiche normative, soprattutto con la recente Legge 90/2024, che ha inasprito le pene e ampliato le ipotesi aggravate del reato. Per un approfondimento rinviamo al contributo specifico sul tema. L’intento del legislatore è stato quello di rafforzare la tutela dei sistemi informatici di particolare rilevanza per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e i servizi essenziali.
Una delle aggravanti più rilevanti riguarda l’accesso abusivo commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. In questi casi, la pena è più severa, poiché l’agente, abusando della propria posizione, accede al sistema con una violazione dei doveri inerenti alla sua funzione, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.
La giurisprudenza ha chiarito che tale aggravante si applica anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio utilizzi le proprie credenziali per scopi diversi da quelli previsti, configurando uno sviamento di potere. Questo tipo di accesso abusivo assume un particolare disvalore sociale, poiché l’abuso della funzione pubblica mette in pericolo la fiducia della collettività nelle istituzioni.
Ulteriore aggravante riguarda i casi in cui l’accesso abusivo provochi danni al sistema informatico, con la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti, oppure l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento. In particolare, la legge n. 90 del 2024 ha introdotto nuove ipotesi aggravate, includendo anche la sottrazione, la riproduzione o la trasmissione non autorizzata dei dati contenuti nel sistema, rendendoli inaccessibili al titolare. Questo tipo di condotta espande significativamente la portata del reato, includendo non solo il danneggiamento fisico o logico del sistema, ma anche l’illecito trattamento delle informazioni.
Infine, il comma 3 dell’art. 615-ter c.p. prevede una ulteriore aggravante per i casi in cui l’accesso abusivo riguardi sistemi informatici o telematici di particolare interesse pubblico. Tra questi rientrano i sistemi legati alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico, alla sanità, alla protezione civile o a qualsiasi altro ambito di interesse pubblico rilevante. In queste ipotesi, la pena può arrivare fino a dodici anni di reclusione, in quanto l’accesso abusivo compromette non solo i singoli interessi privati, ma anche la sicurezza e il buon funzionamento di servizi essenziali per la collettività.
Il reato di accesso abusivo è procedibile d’ufficio nelle ipotesi aggravate, a testimonianza della sua rilevanza e della necessità di una risposta penale più incisiva nei confronti di condotte che mettono in pericolo l’integrità dei sistemi informatici pubblici o di rilevanza nazionale.
Le misure di sicurezza come presupposto dell’ accesso abusivo
Le misure di sicurezza costituiscono un elemento centrale nella configurazione del reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico. L’art. 615-ter c.p. riserva infatti la tutela penale ai soli sistemi che siano protetti da misure di sicurezza, escludendo quelli che, pur essendo accessibili, non sono protetti da barriere che ne limitino l’accesso.
La predisposizione di tali misure è quindi indicativa della volontà del titolare di escludere soggetti non autorizzati, configurando un elemento essenziale per la sussistenza del reato.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, le misure di sicurezza possono essere sia di natura fisica che logica. Le prime comprendono dispositivi come chiavi magnetiche, tessere o altri strumenti fisici che permettono l’accesso diretto ai terminali o agli elaboratori. Le misure logiche, invece, includono l’uso di password, codici di accesso e moderni sistemi di autenticazione, come il riconoscimento biometrico o l’uso di impronte digitali.
Non è richiesto che le misure di protezione siano particolarmente sofisticate o difficili da aggirare: è sufficiente che esse dimostrino la volontà del titolare di limitare l’accesso al sistema a soggetti autorizzati.
Il necessario apprestamento delle misure di sicurezza tende a responsabilizzare il titolare del sistema, che è chiamato a proteggere i propri dati e informazioni attraverso strumenti adeguati. Questo requisito, quindi, funge da filtro per evitare che siano tutelati sistemi che, di fatto, non presentano una volontà effettiva di esclusione. È proprio attraverso la presenza di barriere logiche o fisiche che si può affermare la volontà del titolare di proteggere il proprio spazio informatico da intrusioni indebite. Si tratta dunque di un incentivo forte alla cybersicurezza.
Un aspetto importante da sottolineare è che il reato di accesso abusivo si configura anche se le misure di sicurezza non vengono effettivamente superate dall’agente. Ciò significa che, per integrare la fattispecie criminosa, non è necessario che l’intruso eluda con successo le protezioni. La semplice introduzione abusiva o la permanenza non autorizzata in un sistema protetto da misure di sicurezza è sufficiente a configurare il reato, indipendentemente dal livello di protezione delle barriere predisposte.
Pertanto, ciò che rileva è l’esistenza stessa di tali misure, piuttosto che la loro effettiva efficacia contro l’intrusione.
L’abuso del titolo di legittimazione nell’accesso abusivo
Un aspetto particolarmente complesso del reato di accesso abusivo è la questione dell’abuso del titolo di legittimazione, ovvero la condotta di chi, pur essendo autorizzato ad accedere a un sistema informatico o telematico, ne fa un uso illecito, eccedendo i limiti della propria autorizzazione. Questa fattispecie si verifica tipicamente nel caso di soggetti interni a un’organizzazione, come dipendenti o collaboratori, che utilizzano le proprie credenziali di accesso per scopi diversi da quelli previsti, violando così la volontà del titolare del sistema.
La giurisprudenza ha lungamente dibattuto sull’inquadramento di tali condotte nell’ambito del reato di accesso abusivo. Secondo un primo orientamento, qualsiasi utilizzo delle credenziali di accesso per fini estranei a quelli autorizzati configurerebbe un reato, poiché contrasterebbe con la volontà tacita del titolare di escludere ogni utilizzo illecito del sistema.
Tuttavia, un diverso orientamento ha escluso questa impostazione, sostenendo che il semplice utilizzo improprio delle credenziali non possa integrare il reato di accesso abusivo, a meno che non vi sia una chiara violazione delle disposizioni organizzative che regolano l’accesso al sistema.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Casani del 2011, hanno chiarito che l’abuso del titolo di legittimazione non può configurare il reato di accesso abusivo se l’agente non viola le specifiche prescrizioni che regolano l’accesso al sistema informatico. Secondo questa pronuncia, per integrare la fattispecie è necessario che l’accesso o la permanenza nel sistema siano in contrasto con le regole che ne disciplinano l’utilizzo, non essendo sufficiente il solo uso improprio dei dati ottenuti. In altre parole, la violazione dei limiti di accesso deve riguardare il momento in cui si verifica l’introduzione o la permanenza, e non le finalità successive per cui vengono utilizzati i dati.
Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha continuato a dibattere sulla rilevanza del fine illecito perseguito dall’agente. Un altro orientamento, infatti, ha ritenuto che, nel caso di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, l’utilizzo delle credenziali per scopi diversi da quelli istituzionali possa comunque integrare il reato di accesso abusivo, anche in assenza di una violazione formale delle disposizioni organizzative.
Questo orientamento, sostenuto dalle Sezioni Unite Savarese, ha esteso la nozione di abusività includendo anche l’accesso o la permanenza nel sistema per finalità estranee alle attività per le quali l’autorizzazione era stata concessa, come ad esempio lo sviamento di potere.
L’abuso del titolo di legittimazione, quindi, rappresenta una delle questioni più complesse nella disciplina del reato di accesso abusivo. Mentre l’orientamento più restrittivo richiede la violazione di precise disposizioni organizzative, altre interpretazioni giurisprudenziali attribuiscono rilevanza anche alle finalità per le quali l’accesso è stato utilizzato, ampliando così il perimetro della fattispecie e rendendo più difficile tracciare una linea netta tra condotta lecita e abuso.
Il luogo di consumazione del reato di accesso abusivo
La particolare natura del reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, che si svolge nel cyberspace, pone rilevanti problematiche in merito all’individuazione del luogo di consumazione del delitto. La caratteristica di immaterialità dello spazio virtuale rende complessa la determinazione del locus commissi delicti, ossia del luogo in cui il reato viene considerato consumato e, quindi, del giudice territorialmente competente a conoscerlo.
La giurisprudenza si è a lungo divisa su due orientamenti principali. Il primo individuava il luogo di consumazione del reato nel luogo fisico in cui si trovava il soggetto che accedeva abusivamente al sistema. Secondo questa impostazione, il reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’agente si introduce nel sistema informatico utilizzando il proprio terminale, da remoto o in prossimità del sistema violato. Tale interpretazione si basa sull’idea che il delitto si consuma quando si instaura la connessione logica tra l’agente e il sistema, superando le misure di sicurezza predisposte dal titolare.
Il secondo orientamento, invece, privilegiava l’individuazione del locus commissi delicti nel luogo in cui si trova il server che elabora e controlla le credenziali di accesso fornite dall’agente. In base a questa teoria, il reato si consuma nel luogo in cui è collocato fisicamente il sistema informatico protetto, indipendentemente dal luogo in cui si trova l’autore del reato. Questa tesi si fonda sul principio per cui l’evento lesivo si verifica nel luogo in cui il sistema informatico subisce l’intrusione, e non necessariamente nel luogo da cui essa viene perpetrata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere la questione, stabilendo che il luogo di consumazione del reato di accesso abusivo va individuato nel luogo in cui si trova l’agente al momento dell’introduzione o della permanenza non autorizzata nel sistema. Pertanto, l’orientamento prevalente ritiene che il delitto si consumi nel punto fisico in cui il soggetto attivo opera per accedere abusivamente al sistema, sia esso un luogo remoto o lo stesso luogo in cui è collocato il server.
Questa soluzione giurisprudenziale tiene conto delle peculiarità del cyberspace, pur mantenendo un principio di territorialità nell’individuazione del locus commissi delicti. Ciò risponde all’esigenza di ancorare il reato a un luogo fisico, consentendo così di determinare con maggiore certezza il giudice competente a conoscere del reato di accesso abusivo.
Tuttavia, non mancano casi complessi in cui, data la natura transnazionale del cyberspace, la determinazione del luogo di consumazione del reato richiede un’analisi approfondita della localizzazione dei server e delle modalità tecniche con cui è avvenuto l’accesso abusivo.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di strumenti per l’accesso abusivo
L’art. 615-quater c.p. disciplina un altro importante aspetto connesso al reato di accesso abusivo, ossia la detenzione, diffusione e installazione abusiva di strumenti o codici atti a consentire l’accesso non autorizzato a un sistema informatico o telematico. Questa norma, introdotta con la legge n. 547 del 1993 e successivamente modificata dalla legge n. 90/2024, ha ampliato l’ambito di applicazione del reato, includendo condotte preparatorie che rafforzano la tutela dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati.
L’art. 615-quater c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare un danno, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta a disposizione o installi apparati, strumenti, codici, password o altri mezzi idonei all’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.
La norma copre quindi una vasta gamma di condotte che possono preparare o facilitare l’intrusione in un sistema protetto, anticipando la soglia di punibilità anche a comportamenti che, di per sé, non costituiscono un accesso diretto ma che ne creano le condizioni.
La giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che l’oggetto materiale di questo reato include qualsiasi strumento idoneo a consentire l’accesso abusivo a un sistema informatico. Ciò comprende codici di accesso, password, dispositivi hardware o software appositamente progettati per violare le misure di sicurezza di un sistema informatico. Il legislatore ha adottato una clausola aperta per includere strumenti tecnologici anche di nuova concezione, garantendo così che la norma rimanga applicabile a fronte dei progressi tecnologici.
Inoltre, la legge n. 90 del 2024 ha inasprito le sanzioni previste dall’art. 615-quater c.p., soprattutto in presenza di circostanze aggravanti. Ad esempio, se l’accesso abusivo riguarda sistemi di interesse pubblico o legati alla sicurezza nazionale, la pena può essere significativamente aumentata.
Responsabilità degli enti 231 per accesso abusivo
L’inclusione del reato di accesso abusivo tra i reati presupposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ai senso dell’art. 24-bis, comporta rilevanti conseguenze in termini di responsabilità amministrativa degli enti collettivi.
L’art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla legge n. 48 del 2008 che ha recepito la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, prevede che le aziende e gli enti possano essere chiamati a rispondere qualora si dimostri che la commissione del reato di accesso abusivo sia avvenuta nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Per un approfondimento sulle ipotesi di responsabilità dell’ente da reato informatico rinviamo a un nostro precedente approfondimento.
In questo contesto, la responsabilità dell’ente non deriva dall’eventuale mancata adozione di modelli di organizzazione e gestione che avrebbero potuto prevenire la commissione del reato.
Il D. Lgs. n. 231/2001 introduce infatti un sistema di responsabilità che si basa sull’imputazione dell’illecito all’ente, qualora vi siano carenze organizzative o gestionali tali da consentire il compimento del reato. In assenza di un efficace modello di compliance, che preveda misure idonee a prevenire reati informatici, l’ente può essere considerato responsabile e soggetto a sanzioni.
La responsabilità amministrativa dell’ente si basa su due elementi: l’interesse o il vantaggio che l’ente trae dalla commissione del reato e la colpa organizzativa, ovvero la mancanza di adeguate misure di controllo e prevenzione dei reati. In caso di accertamento della responsabilità, l’ente può essere soggetto a sanzioni pecuniarie, interdittive (come la sospensione dell’attività) e, nei casi più gravi, alla confisca dei beni.
Inoltre, la normativa prevede che l’ente possa dimostrare di aver adottato e attuato efficacemente modelli organizzativi e di gestione, al fine di escludere la propria responsabilità. Tali modelli devono prevedere, tra l’altro, un sistema di vigilanza adeguato alla prevenzione dei reati di accesso abusivo e altre fattispecie informatiche. L’adozione di questi modelli, insieme alla nomina di un organismo di vigilanza, rappresenta una delle principali difese dell’ente in caso di contestazione del reato.
L’introduzione del reato di accesso abusivo nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 sottolinea l’importanza di adottare politiche aziendali di compliance in materia di sicurezza informatica. Le aziende devono quindi dotarsi di strumenti adeguati per prevenire e gestire eventuali attacchi o accessi non autorizzati ai propri sistemi, al fine di evitare conseguenze non solo penali per i soggetti fisici coinvolti, ma anche amministrative per l’ente stesso.
Un modello organizzativo efficace dovrebbe prevedere adeguati presidi anche contro le condotte di accesso abusivo commesse ai danni dei sistemi aziendali interni. Ad esempio, un dipendente potrebbe accedere abusivamente a un’area protetta da misure di sicurezza all’interno del sistema informatico dell’azienda, dove sono archiviate informazioni sensibili.
Tale condotta può avvenire al fine di favorire una società terza, magari nell’acquisizione di un appalto o nell’ottenimento di vantaggi competitivi. In questo contesto, anche se la condotta del dipendente è rivolta nei confronti dei sistemi aziendali, è possibile che essa sia diretta a procurare un vantaggio economico o strategico all’ente stesso.
In questi casi, il reato di accesso abusivo potrebbe essere riconducibile all’interesse o al vantaggio dell’ente, e dunque comportare la responsabilità amministrativa dello stesso ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Diventa quindi essenziale che il modello organizzativo preveda non solo misure di prevenzione generali, ma anche specifici strumenti di controllo volti a monitorare e limitare l’accesso dei dipendenti alle aree sensibili del sistema informatico aziendale.
L’adozione di protocolli di accesso rigorosi e la predisposizione di audit interni possono rappresentare strumenti efficaci per evitare che simili condotte si verifichino e per escludere, in caso di reato, la responsabilità dell’ente.
Conclusioni sul reato di accesso abusivo
Il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico si distingue per la sua complessità e per le peculiarità che lo caratterizzano, richiedendo una conoscenza approfondita non solo delle norme penali, ma anche delle tecnologie informatiche.Per tale ragione, è fondamentale affidarsi a una consulenza legale specialistica sia per la prevenzione che per la repressione di queste condotte.
Il nostro studio offre assistenza qualificata nella difesa in giudizio, fornendo supporto tecnico-giuridico indispensabile per affrontare casi di accesso abusivo.
Sul fronte della prevenzione, ci occupiamo della redazione di modelli organizzativi e codici di condotta interni, volti a disciplinare l’utilizzo delle risorse informatiche aziendali, garantendo così una gestione corretta e sicura dei sistemi e una protezione adeguata contro le condotte illecite.

Assistenza legale per reati informatici e cybercrime – Studio Legale Luca D’Agostino, Roma. Novità dopo la Legge 90/2024.

da Redazione | Ott 23, 2024 | Diritto Penale
La pornografia minorile rappresenta una delle forme più gravi di sfruttamento sessuale, resa ancora più pericolosa dall’ampia diffusione delle reti di comunicazione elettronica. Internet ha permesso agli individui di interagire su scala globale tramite chatroom, social network e servizi di messaggistica, ma questo ha anche creato un ambiente favorevole per la realizzazione di illeciti, inclusa la pornografia minorile e il cyberbullismo.
L’anonimato offerto dalle piattaforme online ha infatti incentivato la creazione, distribuzione e commercializzazione di materiale pedopornografico, rendendo difficile l’identificazione e la persecuzione dei responsabili.
In Italia, il reato di pornografia minorile è regolato dall’art. 600-ter del codice penale, che punisce tutte le condotte che sfruttano sessualmente i minori attraverso la produzione, distribuzione o possesso di materiale pedopornografico. Sebbene la legge sia chiara nella sua definizione, la portata di questo crimine è estesa da una connessione globale, che permette ai colpevoli di operare anche al di fuori dei confini nazionali. Il contrasto al fenomeno richiede quindi non solo una rigorosa applicazione delle norme nazionali, ma anche la cooperazione internazionale.
Un elemento chiave che emerge dalla giurisprudenza è la difficoltà nell’accertare la diffusione del materiale pedopornografico. In particolare, la sentenza delle Sezioni Unite ha chiarito che non è necessario dimostrare il pericolo concreto di diffusione per configurare il reato di produzione di materiale pornografico minorile. Questo rappresenta un importante progresso nel trattamento giuridico del fenomeno, considerando la crescente facilità con cui i contenuti possono essere condivisi su scala globale. La creazione del materiale, infatti, è considerata di per sé lesiva della dignità del minore, indipendentemente dal suo successivo utilizzo.
L’obiettivo di questo articolo è quello di approfondire il fenomeno della pornografia minorile, evidenziando il quadro normativo attuale e i principali orientamenti della giurisprudenza in materia.
Le norme internazionali e sovranazionali contro la pornografia minorile
A livello internazionale, la lotta contro la pornografia minorile ha preso forma attraverso una serie di convenzioni e trattati volti a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori. Tra i principali documenti normativi spicca la Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia del 1989 e il Protocollo Opzionale di New York del 2000, che ha posto l’accento sulla necessità di criminalizzare la produzione, diffusione e possesso di materiale pedopornografico.
Il Consiglio d’Europa ha adottato diverse iniziative normative, tra cui la Convenzione di Budapest sul Cybercrime (2001), che ha rappresentato un pilastro nella criminalizzazione della pornografia minorile. L’art. 9 della Convenzione di Budapest impone agli Stati firmatari di adottare misure legislative per punire una vasta gamma di condotte legate alla pornografia infantile, tra cui la produzione, distribuzione, possesso e accesso consapevole al materiale pedopornografico attraverso sistemi informatici.
A livello comunitario, la Direttiva 2011/92/UE ha sostituito la Decisione quadro 2004/68/GAI, rafforzando ulteriormente il quadro normativo europeo.
L’Italia, in adempimento di tali obblighi, ha emanato una serie di normative, tra cui la L. 23 dicembre 2021, n. 238, che ha aggiornato la definizione e le sanzioni legate alla pornografia minorile, includendo anche il reato di accesso intenzionale a tale materiale. Le iniziative normative internazionali evidenziano l’impegno globale nella lotta alla pornografia minorile, ma resta cruciale la cooperazione tra Stati per rendere effettive queste misure.
Il contrasto alla pornografia minorile nell’ordinamento italiano
In Italia, la legislazione contro la pornografia minorile ha subito diverse modifiche nel corso degli anni per adattarsi all’evoluzione tecnologica e alle esigenze internazionali. Uno dei pilastri del contrasto a questo fenomeno è rappresentato dall’art. 600-ter del codice penale, introdotto con la L. 3 agosto 1998, n. 269, che punisce le condotte di sfruttamento sessuale dei minori, comprese la produzione, distribuzione e commercializzazione di materiale pedopornografico.
I primi due commi sanzionano la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici, la produzione di materiale pornografico, l’induzione minori a partecipare a tali esibizioni o spettacoli, e la commercializzazione di tale materiale. Il terzo comma si riferisce alle condotte di distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione, anche per via telematica del materiale pedopornografico. Il quarto comma punisce, in via residuale, l’offerta e la cessione ad altri del predetto materiale, anche a titolo gratuito.
Il delitto si presenta come un reato di mera condotta a dolo generico. Sebbene le condotte ivi descritte si riferiscano a diversi “segmenti” nella catena di distribuzione del materiale pedopornografico, la possibilità di un concorso di reati è esclusa dalla presenza di clausole di sussidiarietà.
Nell’applicazione giurisprudenziale dell’art. 600-ter, comma 1, si è discusso circa la necessità di accertare – relativamente alla condotta di produzione – il concreto pericolo di diffusione esterna del materiale. Secondo l’orientamento prevalente il pericolo di diffusione del materiale costituiva il discrimen fra la fattispecie in esame e quella residuale di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.).
Il dubbio è stato risolto dalle Sezioni Unite (Cass. Pen. Sez. I, 17 luglio 2018 n. 47086) nel senso della superfluità di un tale accertamento, sulla base di una interpretazione sistematica ed evolutiva della norma incriminatrice. Trattandosi di una fattispecie posta a presidio della dignità del minore in quanto tale non assume rilevanza il pericolo di diffusione esterna: la lesione al bene giuridico si sostanza nella semplice creazione del materiale.
Con riferimento alla condotta di diffusione del materiale realizzata online, la giurisprudenza si è soffermata anche sul locus commissi delicti affermando che la competenza per territorio è dell’ufficio giudiziario nella cui circoscrizione si trova il dispositivo informatico mediante il quale è stato impartito il comando di immissione in rete del materiale pedopornografico (Cass. Pen. Sez. I, 17 luglio 2018 n. 47086).
Il successivo art. 600-quater c.p. punisce in via residuale chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La differenza tra le due condotte sta nel diverso rapporto tra l’agente e il materiale: mentre il “procurarsi” è una azione istantanea, il “detenere” configura un reato permanente, la cui consumazione coincide con la cessazione della detenzione (Cass. Pen., Sez. III, 23 febbraio 2016 n. 15719).
Le due condotte sono alternative ai fini della commissione delitto: secondo la giurisprudenza prevalente si tratta di due diverse modalità commissive che non possono concorrere tra loro se riguardano lo stesso materiale pedopornografico (Cass. Pen., Sez. III, 25 maggio 2017 n. 38221).
Con la riforma del 2006 il predicato “dispone” è stato sostituito con “detiene” il che pone l’accento sull’irrilevanza del mero accesso a un sito Internet contenente il predetto materiale. La scelta è stata confermata dalla legge del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote; il legislatore italiano sembra essersi avvalso della facoltà, prevista dall’art. 20, comma 4, della Convenzione, di non sanzionare l’accesso consapevole, mediante le tecnologie dell’informazione, al materiale in parola.
Sul punto la giurisprudenza aveva precisato che la mera visualizzazione del materiale su Internet, senza la consapevolezza che a seguito della navigazione in rete una copia delle immagini visualizzate viene automaticamente salvata dal browser nella memoria temporanea del sistema informatico (c.d. copie cache), non integra gli estremi dell’art. 600-quater (Cass. Pen., Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 12458. Contra v. Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2010, n. 43246, la quale ha sancito l’equivalenza, ai fini della prova della condotta di detenzione, tra il materiale pedopornografico scaricato ed i files temporanei di Internet).
Soltanto con la L. 23 dicembre 2021, n. 238 la fattispecie è stata modificata per introdurre il delitto di accesso intenzionale a materiale pedopornografico, che si affianca al reato di detenzione di tale materiale già disciplinato dall’art. 600-quater.
Il consenso del minore e la produzione di pornografia minorile “domestica”: evoluzione giurisprudenziale
Tra le questioni più complesse e dibattute in relazione alla pornografia minorile vi è quella del consenso prestato dal minore ultraquattordicenne nella produzione della cosiddetta “pornografia domestica”. Per molti anni, la giurisprudenza ha sostenuto l’ontologica invalidità del consenso del minore, anche se maggiore di quattordici anni, alla produzione di materiale pornografico, soprattutto quando tale produzione avveniva nell’ambito di una relazione con un soggetto maggiorenne.
Il consenso del minore, in altre parole, era considerato irrilevante in quanto incapace di legittimare una condotta che violava la sua dignità e integrità sessuale.
Tuttavia, di recente, la giurisprudenza ha modificato tale orientamento, attribuendo maggiore importanza all’inciso contenuto nel primo comma dell’art. 600-ter e dell’art. 600-quater del codice penale, secondo cui il reato di pornografia minorile si configura quando viene “utilizzato” un minore di anni diciotto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 novembre 2018, n. 51815, hanno chiarito che il termine “utilizzazione” deve essere inteso in senso dispregiativo, indicando la trasformazione del minore da soggetto dotato di dignità sessuale in mero strumento per il soddisfacimento dei desideri sessuali di terzi o per ottenere utilità di vario genere.
Questo chiarimento è stato necessario a seguito di un contrasto interpretativo tra diverse pronunce giurisprudenziali. Le Sezioni Unite sono poi intervenute nuovamente con la sentenza del 28 ottobre 2021, n. 4616, per risolvere la questione se la produzione di materiale pornografico con il consenso di un minore ultraquattordicenne, nell’ambito di una relazione con un adulto, costituisca reato di pornografia minorile ai sensi dell’art. 600-ter, primo comma.
Con un articolato iter motivazionale, la Corte ha stabilito che il consenso che un minore ultraquattordicenne può prestare per atti sessuali ex art. 609-quater c.p. si estende anche alla riproduzione visiva di tali atti, purché le immagini o i video siano frutto di una scelta libera e consapevole e siano destinati a uso esclusivo dei partecipanti all’atto. Tuttavia, qualora queste immagini siano destinate fin dall’inizio alla diffusione, si configura comunque il reato di produzione di materiale pedopornografico ai sensi dell’art. 600-ter, primo comma.
Inoltre, le condotte di diffusione e cessione del materiale, disciplinate dal terzo e quarto comma dello stesso articolo, sono sanzionabili anche quando il materiale sia stato inizialmente prodotto in modo legittimo. Questo principio evidenzia come la giurisprudenza abbia voluto porre un freno alla diffusione non autorizzata di contenuti che, sebbene originati con il consenso del minore, possono comunque offendere la sua dignità.
Un altro aspetto importante riguarda la riforma introdotta con la L. 23 dicembre 2021, n. 238, che ha previsto un nuovo reato di atti sessuali con minorenne compiuti abusando della fiducia acquisita o dell’autorità esercitata su di lui. Sarà compito della giurisprudenza futura chiarire se il principio enunciato dalle Sezioni Unite riguardo alla pornografia minorile domestica potrà essere applicato anche alle nuove fattispecie previste dal terzo comma dell’art. 609-quater c.p., relative agli atti sessuali abusivi compiuti in contesti di fiducia o autorità.
Altrettanto dibattuta, soprattutto nella prassi applicativa, è la rilevanza penale del sexting tra minori, ossia la produzione e condivisione consensuale di immagini intime. Alcune pronunce, come quella della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 11675 del 18 febbraio 2016, hanno affermato che il sexting tra minori non costituisce reato di produzione di pornografia minorile ai sensi dell’art. 600-ter, comma 4, c.p., a meno che il materiale non venga prodotto da un soggetto terzo rispetto al minore. Secondo questa interpretazione, la mera autoproduzione di immagini intime da parte di un minore non integra gli estremi del reato di pornografia minorile.
Più di recente, però, la Corte di Cassazione ha rivisto questa posizione con la sentenza del 21 novembre 2019, n. 5522, stabilendo che per configurare le ipotesi di reato previste dai commi da due a cinque dell’art. 600-ter c.p., non è necessario che la produzione del materiale avvenga per mano di un soggetto diverso dal minore stesso. In sostanza, per il reato di produzione di pornografia minorile di cui al primo comma dell’art. 600-ter, è richiesta l’alterità tra il soggetto ritratto e l’autore del materiale, mentre per gli altri commi non rileva la modalità di produzione delle immagini, che possono essere sia eteroprodotte sia autoprodotte.
Infine, occorre sottolineare che le condotte di diffusione e cessione del materiale pedopornografico (art. 600-ter, commi 3 e 4), nonché la detenzione dello stesso (art. 600-quater), sono aggravate nel caso in cui il materiale sia di ingente quantità, un’aggravante che sottolinea la gravità del fenomeno e la necessità di una repressione severa e incisiva da parte delle autorità.
Pornografia minorile e child grooming
L’art. 609-undecies del codice penale, introdotto con la L. 1° ottobre 2012, n. 172, ha previsto il reato di child grooming, ossia l’adescamento di minori. Questo reato, inserito per dare attuazione alla Convenzione di Lanzarote, risponde alla necessità di contrastare in modo efficace il fenomeno del child grooming, che prelude spesso a forme più gravi di sfruttamento sessuale, tra cui la produzione di pornografia minorile. Secondo la legge, l’adescamento consiste in “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce”, allo scopo di coinvolgerlo in attività sessuali.
Ciò che rende particolarmente insidioso il reato di child grooming è il fatto che può essere punito anche in assenza di atti esecutivi del reato sessuale.
Si tratta, infatti, di un reato di pericolo concreto, in quanto l’adescamento viene sanzionato anche quando non è stato consumato alcun reato di sfruttamento sessuale vero e proprio. L’art. 609-undecies punisce quindi la condotta preparatoria volta a creare un contatto con il minore per fini illeciti, anticipando la tutela penale.
A differenza di altre forme di reato legate alla pornografia minorile, il grooming è perseguito anche quando non vi sia stata una proposta di incontro tra l’agente e il minore, “anche in assenza di una proposta di incontro con il minore”.
Un aspetto significativo della disciplina del grooming in Italia è che l’utilizzo di internet per adescare minori rappresenta solo una delle modalità di realizzazione del reato, non essendo obbligatoria la mediazione tecnologica.
Tuttavia, l’uso di mezzi telematici può aggravare la condotta, soprattutto se l’autore del reato utilizza tecnologie che rendono difficile la sua identificazione. In questi casi, l’art. 609-duodecies c.p. prevede un aggravamento della pena per l’utilizzo di “mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche”, evidenziando come l’elemento informatico renda più complessa la prevenzione e la repressione del fenomeno della pornografia minorile.
La giurisprudenza italiana ha più volte affrontato il tema del grooming, chiarendo che per configurare il reato è sufficiente che l’agente compia atti volti a guadagnare la fiducia del minore, anche senza una concreta esecuzione di atti sessuali.
Ad esempio, la Corte di Cassazione, Sez. III, nella sentenza n. 26730/2019, ha stabilito che “il semplice utilizzo di mezzi telematici per instaurare un contatto con il minore può essere sufficiente per configurare il reato”, anche se non vi sia stato un incontro fisico.
La L. 23 dicembre 2021, n. 238, ha introdotto ulteriori aggravanti per il reato di grooming, prevedendo un aumento della pena se il reato viene commesso “da più persone riunite, o da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività”. Parimenti la pena è aumentata se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave, o se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
In conclusione, il child grooming costituisce una minaccia crescente nell’era digitale, e l’ordinamento italiano ha adottato misure preventive per reprimere questa condotta, in particolare quando è finalizzata alla produzione o diffusione di materiale pedopornografico. Le nuove tecnologie, pur facilitando la commissione di tali reati, hanno trovato un argine nella normativa italiana, che continua a evolversi per proteggere i minori dagli abusi.
La repressione della pornografia minorile. L’importanza dell’assistenza legale.
La pornografia minorile continua a rappresentare una delle forme più gravi e allarmanti di sfruttamento sessuale. L’evoluzione tecnologica ha indubbiamente amplificato la portata di questo fenomeno, rendendo sempre più facile la creazione e la diffusione di materiale pedopornografico su scala globale.
Le reti telematiche e le piattaforme digitali, con il loro elevato grado di anonimato, offrono un terreno fertile per la proliferazione di contenuti illeciti, ponendo una sfida enorme per le autorità di contrasto. Tuttavia, il quadro normativo italiano, in costante aggiornamento, ha cercato di rispondere in modo efficace a questa minaccia, attraverso una legislazione rigorosa che mira a proteggere i minori sotto ogni aspetto.
L’introduzione di nuove fattispecie di reato, come l’adescamento di minori (child grooming) e l’accesso intenzionale a materiale pedopornografico, riflette l’impegno del legislatore italiano nell’anticipare la tutela penale e nel contrastare anche le condotte preparatorie che possono portare alla realizzazione di crimini più gravi.
Inoltre, la giurisprudenza ha svolto un ruolo fondamentale nell’interpretare e applicare queste normative, adeguandosi all’evoluzione delle tecnologie e delle dinamiche criminali connesse alla pornografia minorile.
Nonostante questi progressi normativi e giurisprudenziali, il problema della pornografia minorile richiede un approccio sempre più integrato, che coinvolga non solo le forze dell’ordine e le istituzioni giudiziarie, ma anche la società civile e gli operatori del settore tecnologico.
La prevenzione e il contrasto di questo fenomeno non possono prescindere da una cooperazione internazionale, poiché il crimine si sviluppa spesso in un contesto transnazionale. Allo stesso tempo, è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere i minori dai rischi legati all’uso non consapevole delle tecnologie.
In questo scenario complesso, il nostro studio legale offre un supporto qualificato e dedicato alle vittime di pornografia minorile e ai loro genitori.
Con una profonda conoscenza della materia e un’attenzione costante all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, forniamo assistenza legale sia alle vittime sia alle loro famiglie, affiancandole in tutte le fasi del procedimento penale. Il nostro obiettivo è garantire che le vittime ottengano giustizia, tutelando i loro diritti e proteggendo la loro dignità.

Pornografia minorile e reati informatici: la minaccia crescente nell’era digitale. Assistenza legale dedicata per contrastare lo sfruttamento dei minori.